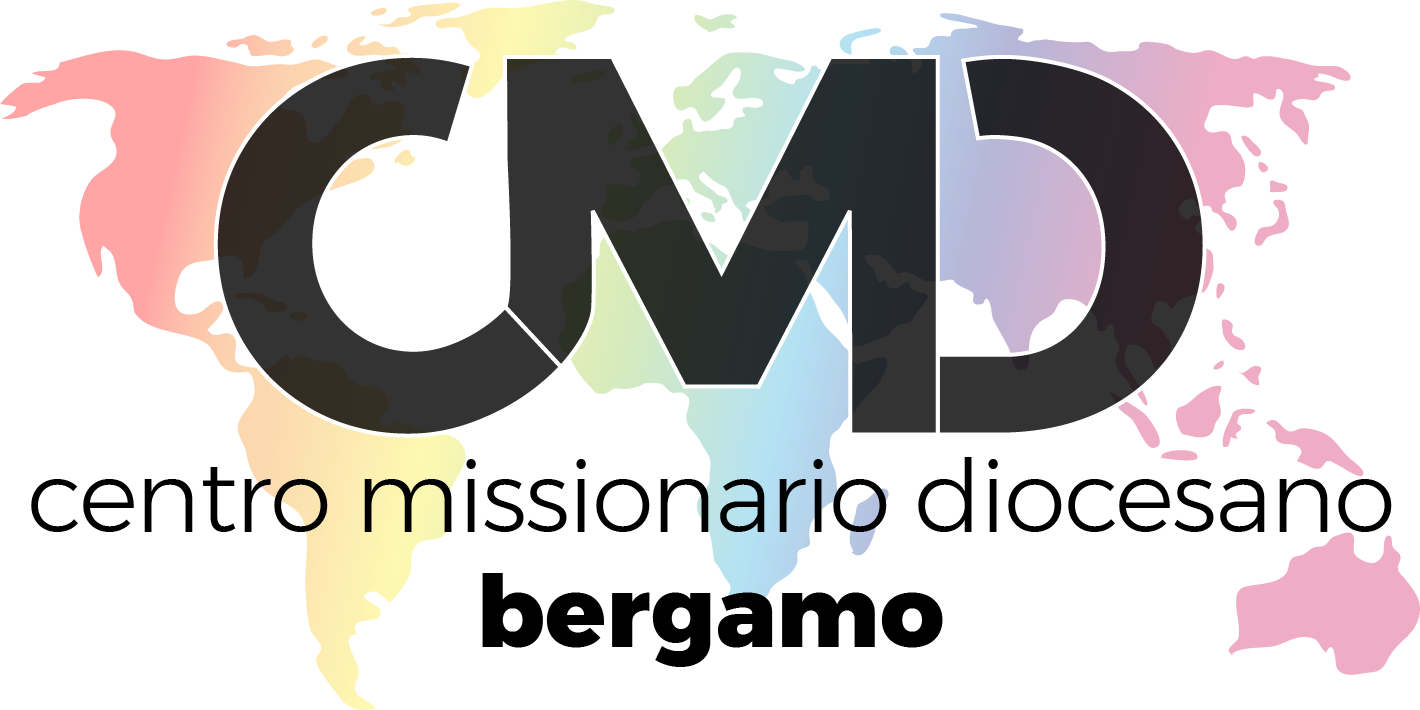Giovani per il vangelo

CINA (parte 1)
Un fatto saliente delle ultime settimane è la storica firma tra Cina e Vaticano di un trattato “provvisorio” riguardante la questione dei vescovi.
Così dice il comunicato:” Nel quadro dei contatti tra Santa Sede e Repubblica Popolare Cinese che sono in corso da tempo per trattare questioni ecclesiali di comune interesse e per promuovere ulteriori rapporti di intesa, oggi, 22 settembre 2018, si è svolta a Pechino una riunione tra mons. Antoine Camilleri, Sotto-Segretario per i Rapporti della Santa Sede con gli Stati, e S.E. Il Sig. Wang Chao, viceministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, rispettivamente capi delle delegazioni vaticana e cinese. Nel contesto di tale incontro i due rappresentanti hanno firmato un Accordo Provvisorio sulla nomina dei Vescovi”.
L’accordo ” tratta della nomina dei Vescovi, questione di grande rilievo per la vita della Chiesa, e crea le condizioni per una più ampia collaborazione a livello bilaterale”. Con l’auspicio condiviso che “tale intesa favorisca un fecondo e lungimirante percorso di dialogo istituzionale e contribuisca positivamente alla vita della Chiesa cattolica in Cina, al bene del Popolo cinese e alla pace nel mondo”.
Si tratta di un accordo storico che non riguarda le relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Cina, ma l’annosa questione delle modalità di selezione e nomine vescovili.
Le parti hanno concordato il metodo di una soluzione condivisa: la Santa Sede accetta che il processo di designazione dei candidati all’episcopato avvenga dal basso, dai rappresentanti della diocesi anche con il coinvolgimento della Associazione patriottica, mentre il governo cinese da parte sua accetta che la decisione finale, con l’ultima parola sulla nomina, spetti al pontefice, che rilascia la lettera di nomina.
Inoltre anche i sette vescovi che erano stati nominati precedentemente senza l’approvazione del Papa, dei quali era stata dichiarata la scomunica, saranno riammessi canonicamente di modo per la prima volta da oggi tutti i vescovi cinesi sono in comunione con Roma.
Questa è anche la prima volta che il governo cinese, che in precedenza si arrogava il diritto di scelta dei vescovi, riconosce il ruolo del Pontefice come guida spirituale e gerarchica della Chiesa.
(Fonte: Avvenire 22 settembre 2018)
CINA (parte 2)
Facciamo un passo indietro per capire la ferita profonda che viene a sanare l’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese in merito alla questione dei vescovi.
Si parla spesso di due chiese in Cina, l’una Clandestina (che sarebbe l’unica fedele a Roma) e l’altra “Patriottica” (che sarebbe invece appiattita sulle posizioni del Partito comunista cinese).
In realtà le cose non sono precisamente così: esiste una sola Chiesa che, per ragioni storiche, vive una divisione in due parti. Tutto è cominciato nel 1958 quando vennero consacrati i primi vescovi illegittimi, cioè senza l’approvazione del papa.
Nella Cina che si accingeva a vivere gli anni drammatici del “Grande balzo” in avanti e la creazione delle Comuni popolari, nell’aprile 1958, ebbe luogo a Hankou la prima consacrazione episcopale autonoma, dopo che il mese precedente si era avuta “l’elezione democratica” del candidato vescovo, il francescano Bernardino Dong Guangqing.
La storia in realtà è un poco complessa: Bernardino Don era un frate minore molto stimato dai suoi superiori e benvoluto dalla gente. Nei primi anni cinquanta, per ordine di Mao, i missionari stranieri vennero espulsi dalla Cina come “nemici del popolo”; tra questi figurava anche mons Maurizio Rosà, vescovo di Hankou.
P Bernardino, che si distinse per la resistenza alla politica religiosa del governo di Mao, venne prima arrestato, e in seguito subì periodi di isolamento e rimase sotto sorveglianza.
Una volta espulso il vescovo, Dong , che era il più anziano tra i francescani rimasti in diocesi, ritenne di doverne assumere la guida della diocesi in base al regolamento previsto dal diritto canonico. Venne riconosciuto da Roma come vicario capitolare.
Nel 1957 ebbe luogo a Pechino la Assemblea di fondazione dell’Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi (che diede origine alla cosidetti Chiesa Patriottica), che aprì la strada all’ordinazione, indipendente da Roma, di nuovi vescovi cinesi scelti dalle autorità del partito.
Tra i candidati vescovi, per la stima che aveva presso i suoi superiori e presso il popolo, venne scelto proprio p. Dong. Dopo questa “elezione episcopale democratica” e prima della consacrazione p. Dong fece di tutto, in una situazione in cui comunicare era oltremodo difficile, per mettersi in contatto con Roma e informare degli avvenimenti, nonché per confermare alla Santa sede la volontà di restare fedeli al Papa.
Tutto questo avveniva normalmente per mezzo di telegrammi; e le risposte della Santa sede arrivavano allo stesso modo. Da Roma arrivò l’ordine perentorio di non accettare la consacrazione: i toni severi di Roma indussero i religiosi coinvolti nella vicenda a pensare di non essere stati capiti.
Padre Dong, credendo che l’incomprensione si sarebbe presto sanata e forte della grande stima che aveva sempre avuto presso i suoi superiori, accettò e fu consacrato vescovo il 13 aprile 1958 da Mons. Li Daonan, vescovo in piena comunione con il papa.
Mons. Dong diventò così il primo vescovo cinese illegittimo (in quanto non scelto da Roma), ma la cui consacrazione era valida (consacrato da un vescovo nel rispetto della successione apostolica).
In tutti questi anni, certamente uno dei passi più importanti nel cammino verso la comunione lo fece Papa Benedetto XVI che nel 2007 inviò una coraggiosa “Lettera ai cattolici cinesi” chiedendo la riconciliazione tra “Patriottici” e “Clandestini” e istituì la Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina ogni 24 maggio, festa di Maria Ausiliatrice.
(Fonte: Avvenire 31 agosto 2018)
AMAZZONIA
Dopo il sinodo sui giovani che si celebra in questi giorni, papa Francesco ha annunciato un Sinodo speciale per l’Amazzonia, il polmone verde del pianeta, luogo dove la biodiversità naturale e quella umana (la abitano 390 popoli differenti) vanno di pari passo.
Il card Hummes, arcivescovo di San Paolo, così la definisce: “Una regione meravigliosa, dove la foresta custodisce l’acqua e l’acqua custodisce la foresta e dove i popoli originari custodivano e custodiscono la preservazione di questo santuario della natura”.
Papa Francesco durante la visita in Perù dello scorso gennaio, ha detto che ” i popoli originari dell’Amazzonia non sono mai stati tanto minacciati nei loro territori come oggi”.
E la minaccia nasce dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse di questa terra grande pressapoco 16 volte l’Italia.
Il nostro stile di vita, esagerato, lo pagano a caro prezzo popoli che da sempre hanno convissuto con la madre terra creando un equilibrio che sta per andare irrimediabilmente perduto.
Per finire ancora alcune parole pronunciate da papa Francesco in Perù parlando ai popoli dell’Amazzonia:
“Permettetemi di dirvi che se, da qualcuno, voi siete considerati un ostacolo o un “ingombro”, in verità, voi con la vostra vita siete un grido rivolto alla coscienza di uno stile di vita che non è in grado di misurare i suoi costi. Voi siete memoria viva della missione che Dio ha affidato a tutti noi: avere cura della casa comune”.
(Fonte: Mondo e missione. Marzo 2018 pg 12-15)
THAILANDIA
In questi giorni facendo passare alcune riviste missionarie mi è capitato di incontrare la testimonianza di suor Maria Angela Bertelli, saveriana di Carpi, missionaria in varie parti del mondo, dai bassifondi di New York, passando per la guerra civile in Sierra Leone dove venne sequestrata per due mesi con altre sei consorelle, fino ad arrivare agli slum di Bangkok dove è vissuta per sedici anni.
Sono luoghi di miseria e di abbandono, come molte periferie cittadine del mondo.
La missione, dice “Suor Angela, è là dove il cuore dell’uomo è veramente distrutto, ai confini dell’umano, …. anche nei contesti più degradati si può trovare tanta umanità”.
Ed è proprio da qui che si può provare a costruire il bene .
E ancora:” Parte tutto dal cuore delle persone. Quando non si vede l’altro come tuo fratello, con la tua stessa dignità, in quanto anche lui figlio di Dio- perché nero, perché povero, perché disabile…- allora non si salva più nessuno.”
La suora, ora rientrata in Italia, ricorda che nel 2008 insieme ad alcune consorelle venne aperta a Bangkok la “Casa degli Angeli”, per accogliere mamme, perlopiù donne sole, abbandonate dai loro mariti, con bambini disabili.
Oltre alla fatica legata alla disabilità, queste mamme dovevano sopportare anche lo stigma sociale che forte pesava su di loro e i loro figli: nella cultura buddista infatti l’handicap fisico e la disabilità sono percepiti come una maledizione, una punizione per errori commessi in una vita precedente.
La cosa più difficile era far capire a queste madri che non c’era nessuna maledizione e tantomeno nessuna ragione per giustificare l’esclusione sociale di questi esseri più deboli.
La lettura del vangelo era lo strumento privilegiato non tanto per convertire, quanto per aiutare queste donne a vedere se stesse e i loro figli come voluti, creati e amati da Dio.
C’è una bella preghiera che termina più o meno con queste parole: “Ognuno di noi è un pò di terra che un giorno Dio ha baciato”.
(Fonte: Mondo e Missione marzo 2018 pg 22-24)
CAMERUN
La parte più a nord del Camerun, quella che si insinua tra Ciad e Nigeria fino ad arrivare al lago Ciad, un grande lago che si sta prosciugando, sta passando un periodo di grave carestia che sta mettendo in pericolo la vita di almeno tre milioni di persone che rischiano di morire di fame.
Allargando lo sguardo verso il Ciad e la zona del Sahel, le persone a rischio sarebbero più del doppio, circa sette milioni. Sono zone in cui siccità e carestie si presentano saltuariamente: questa volta però è diverso e la situazione è di una gravità esagerata.
La continua mancanza di piogge ha fatto perdere i raccolti e non c’è niente da mangiare. A questo si aggiunge il fatto che in questa parte del Camerun sono arrivate decine di migliaia di persone in fuga dalla violenza di Boko Haram, che colpisce già da qualche anno il nord della Nigeria.
L’allarme carestia era già stato lanciato alla fine dell’anno scorso, però niente è stato fatto per aiutare questa gente. I missionari presenti affermano che la situazione è drammatica.
Padre Danilo Fenaroli del Pime dice:”Ci troviamo di fronte a una situazione di grave emergenza. Famiglie intere non hanno più niente da mangiare perchè i raccolti, nella migliore delle ipotesi, sono stati scarsi e, in molti casi, completamente inesistenti”.
E continua Bouba, un contadino del posto: “In vita mia non ho mai visto tanta gente soffrire la fame”.
Molti di quelli che conosco ormai mangiano solo una volta al giorno. E solo miglio.” In questa parte del Camerun la maggior parte della popolazione è mussulmana; la chiesa rappresenta solo una piccolissima parte della popolazione, ma è attivamente impegnata ad alleviare le sofferenze di tutti.
Come se non bastasse sembra che grossi branchi di elefanti, anche loro mossi dalla fame distruggono tutto quello che trovano. Le cose potrebbero andare meglio se il Lago Ciad fornisse acqua per l’agricoltura.
C’è un progetto nel cassetto per salvare il lago Ciad e con lui la vita di milioni di persone: si chiama Transaqua e prevede la costruzione di un canale di 2.440 chilometri che dal bacino del fiume Congo (Repubblica democratica del Congo) porti le acque direttamente al fiume Ciad.
Il progetto ha trentanni ed è stato pensato dalla Società Italiana di Bonifica: l’instabilità politica e la mancanza di finanziamenti, la causa del ritardo.
Sono necessari 14 miliardi di euro, e la realizzazione è ardua… e comunque non tutti sono d’accordo.
(Fonte: Mondo e missione. Giugno-luglio 2018 pp 22-24 )
MAURITANIA
È un dato storico assodato che la schiavitù, nell’accezione comune che ha questa parola, non esiste più. Non stiamo parlando delle nuove forme di schiavitù, quali la tratta degli umani, l’industria del sesso, lo sfruttamento lavorativo di minori e adulti, ma di schiavitù vera e propria.
Eppure c’è una nazione in cui la schiavitù, sebbene abolita da una legge del 1981, sopravvive tuttora. Stiamo parlando della Mauritania, paese dal quale provenivano e forse provengono ancora oggi, molti degli schiavi sfruttati nei paesi arabi produttori di petrolio.
Non parliamo però della schiavitù di “esportazione”, ma di quella che vi vive nella stessa Mauritania: gli sfruttatori sono arabi-berberi, gli sfruttati sono chiamati Haratim (erano gli schiavi prima della legge del 1981).
Le ragioni di questa persistenza e accettazione, nonostante la legge abbia abolito la schiavitù, è dovuta in parte al forte radicamento di questa abitudine e alla legittimazione religiosa, fornita da una interpretazione dell’islam propria di questo popolo.
Una decina di anni fa è sorto il movimento Ira Mauritanie, che mira ad una abolizione concreta e completa della schiavitù in questo paese. Il fondatore di tale movimento si chiama Biram Dah Abeid e si è candidato alle elezioni presidenziali del 2019.
Non è facile il loro lavoro ed è contrastato in molti modi. Racconta Biram:” Spesso succede che quando si viene a sapere del nostro intervento (per liberare persone che vivono in schiavitù), il padrone si reca in via preventiva dai gendarmi e chiede loro di spaventare lo schiavo, minacciandolo con future punizioni se parlerà dicendo la verità.
Così, per esempio è successo con la sorella di Bilal la quale era stata intimidita; quando siamo andati a cercarla, accompagnati dalle forze dell’ordine, ha iniziato a piangere e a mentire dicendo che si trovava lì di sua volontà, che era libera e contenta della sua condizione… Alla fine però è venuta via con noi e solo quando si è sentita al sicuro ci ha raccontato degli stupri e delle punizioni corporali che subiva, ma anche delle minacce dei gendarmi.
Infine, come se non bastasse, i bambini haratim (figli degli schiavi), non è previsto che vadano a scuola, a meno che la bontà del padrone lo consenta.
(Fonte: Mondo e Missione maggio 2018 pg 40)
SUD SUDAN
Il Sud Sudan è il più giovane stato africano. Nasce il 9 luglio 2011, staccandosi dal resto del Sudan a seguito di un referendum passato con quasi il 99 per cento dei voti.
Nel dicembre 2013 però è scoppiato un conflitto etnico fra le forze governative del presidente Kiir, di etnia Dinka e i fedeli dell’ex vicepresidente Machar, di etnia Nuer.
Tutto questo ha dato inizio a un esodo senza fine. Più di 2 milioni di profughi hanno lasciato il paese e più della metà di questi è andata in Uganda. Sono perlopiù donne e bambini; pochi gli anziani e meno ancora i giovani, tutti presi dai combattimenti.
Sono vite sospese, dove la cosa più incerta è il futuro. Scappano dalla guerra e dalla fame. La zona dove si rifugiano si trova nel nord dell’Uganda, confinante con l sud Sudan; la parte più povera dell’Uganda, a sua volta segnata da conflitti interni, che però si sta dimostrando molto accogliente.
I profughi, al loro arrivo, passano pochi giorni nei campi di raccolta e poi sono distribuiti sul territori: ad ognuno viene dato un pezzo di terra, le Nazione Unite garantiscono un pò di riso, fagioli, olio, sale ogni mese ad ogni persona, poi ognuno deve tirare avanti come può.
A tutti è dato l’accesso all’istruzione e alla sanità, sebbene le istituzioni siano molto fragili. Credo sia un bell’esempio anche per noi, abituati il più delle volte ad affrontare la questione profughi tra paure e pregiudizi.
DI certi il fatto di possedere poco, aiuta ad essere più accoglienti. E’ molto bella anche la testimonianza dei missionari presenti in queste zone: molti di coloro che vivevano nel Sua Sudan, hanno lasciato questa terra ormai spopolata, per seguire, esuli con gli esuli, la loro gente nel nord dell’Uganda. (Fonte: Mondo e Missione genn 2018 pg 6-11)
ETIOPIA-ERITREA
Uno degli avvenimenti più significativi di quest’anno è stata la pace siglata tra Etiopia ed Eritrea, dopo 20 anni di conflitto. Il tutto era cominciato nel 1991 con la cacciata del leader comunista Menghistu; gli eritrei non perdono tempo, organizzano un referendum e proclamano l’indipendenza nel 1993. Ci sono però questioni irrisolte riguardo ai confini (uno sbocco sul mare per l’Etiopia), e la città contesa di Badmè.
Nel 1998 scoppia la guerra, tra la nobile indifferenza del mondo. Termina nel 2000, ma gli accordi di pace siglati con la mediazione dell’Onu restano lettera morta e le truppe etiopi hanno continuato ad occupare l’Eritrea fino a pochi mesi fa.
Il miracolo della pace vede come suo protagonista il primo ministro etiope Abiy Ahmed, 41 anni, uno dei leader più giovani dell Africa. Appartenente alla fazione degli Oromo, ha stretto un accordo con i rivali Tigrini per poter muovere i primi passi verso la pace; poi la mediazione degli Emirati Arabi Uniti e di Arabia Saudita ha aiutato per il resto.
L’abbraccio tra Abiy Ahmed e il dittatore eritreo Issaias Afewerki avvenuto lo scorso 8 luglio ha dato inizio a una nuova fase storica: il processo non sarà facile però perlomeno si è cominciato.
Soprattutto potrebbe cambiare qualcosa per gli eritrei, dato che il dittatore aveva sospeso la costituzione, proibito libere elezioni, stabilito il servizio militare a vita: questo ha provocato un esodo continuo di eritrei, almeno 5000 al giorno, verso l’Etiopia, per non parlare di quelli che cercano di venire in Europa con i barconi. È una grande speranza da seguire con attenzione nel tempo, per una zona martoriata della terra di Africa.
(Agenzie Agi e Avvenire)
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
La Repubblica Democratica del Congo è una delle nazioni più grandi e popolose dell’Africa, nonché tra le più ricche in materie prime. E normalmente dove ci sono materie prime, la stabilità politica si trasforma in una chimera. E la Repubblica Democratica del Congo non fa eccezione.
Sullo sterminato territorio della Repubblica democratica del Congo operano decine di organizzazioni armate nazionali e straniere e il Paese da oltre 20 anni è teatro di conflitti armati, alimentati soprattutto dalla concorrenza per il controllo delle risorse minerarie della regione orientale del Paese, sopratutto il Nord Kivu, e dalla rivalità tra i vari gruppi regionali.
Nell’ultimo anno, peraltro, la situazione si è fatta incandescente anche nella regione centrale del Kasai, dove secondo un rapporto della Chiesa locale le vittime degli scontri tra forze governative e milizie sono state oltre 3 mila.
Comunque, 20 anni di guerra, o guerriglia che dir si voglia, hanno fatto 6 milioni di morti, 4 milioni di sfollati e 1,5 milioni di persone “a rischio fame”.
E tutto questo, ancora una volta, tra l’indifferenza generale. Indifferenza funzionale a quei paesi che nel frattempo stanno saccheggiando le preziose risorse di coltan (tantalio) che si trovano nel Kivu: sono le riserve più grandi del mondo.
Il coltan fino a pochi anni fa valeva pochissimo e nessuno voleva estrarlo: spaccarsi la schiena rompendo pietre sotto il sole per poco o niente, non interessava a nessuno.
A vederlo è come un fango di sabbia nera con qualche debole scintilla di luce, come fosse quarzo. Se gli si avvicina una calamita si attacca.
In questi ultimi anni è richiestissimo dall’industria ultratecnologica per la miniaturizzazione di cellulari, computer e cose del genere; inoltre serve per ottimizzare il consumo della corrente elettrica nei chip di nuovissima generazione. Ormai è considerato un minerale di importanza economica e strategica immensa.
La strategia è sempre la stessa: i gruppi interessati allo sfruttamento minerale (sempre umili imprese occidentali o cinesi), corrompono i capi con denaro (e non è per niente difficile), armano le tribù, che normalmente qualche rancore reciproco ce l’hanno sempre, e la cosa è fatta.
Mentre la gente del posto si ammazza o è sfruttata a livello disumano nelle stesse miniere, i ladri del mondo civilizzato caricano ogni giorno aerei pieni del pregiato minerale che servirà per i regali più graditi e ambiti da grandi e piccini: cellulari, computer, play-station e cose del genere.
Papa Francesco non si stanca di richiamare l’attenzione su questa come su altre situazioni di guerra, ma tutti, pare hanno interesse che continuino.
La cosa inoltre si sta complicando per la violenza del regime di Kabila, il dittatore super-corrotto del momento. La chiesa cattolica , vescovi, preti e popolo, sono in prima linea per difendere la libertà e cercare la pace. L’unica cosa interessante
(Fonte: Mondo e Missione aprile 2018 pg 6-7, wikipedia e agenzie di stampa)
COSTA RICA
Qualcuno, come per esempio la rivista missionaria Popoli e Missione del gennaio scorso, lo definisce il paese più felice del mondo.
Per esempio il Costa Rica quest’anno celebra l’anniversario dei suoi 70 anni senza esercito. Nel 1948 il presidente Josè Figueres Ferrer fu il primo capo di stato al mondo a decretare l’abolizione dell’esercito con norma costituzionale.
Così mentre nel mondo una delle voci più grosse tra le spese dei vari stati è quella per gli armamenti, il Costa Rica ha pensato bene di investire questo denaro in infrastrutture, ambiente, educazione e welfare, con risultati sorprendenti, sia per l’aspettativa di vita della sua gente, che per la qualità di vita dei suoi 5 milioni di abitanti.
L’ordine pubblico e le frontiere sono garantite dalla polizia; è l’unico paese dell’America Latina a non aver registrato colpi di stato in questi ultimi decenni e questo dovuto al fatto di non avere un esercito.
È però pur vero che l’abolizione dell’esercito e la conseguente vendita delle armi ai paesi vicini, Guatemala, El Salvador e Nicaragua, provocò negli stessi un aumento della violenza.
Un problema di cui risente anche questa terra è quello della droga, dovuto al fatto di essere sulle rotte dei narcotrafficanti che vanno a vendere al nord: il fatto di investire molto nell’educazione delle giovani generazioni sta aiutando Costa Rica a contenere il problema.
L’Italia spende ogni anno 23,6 miliardi di euro in armamenti: è il valore di una mezza finanziaria e posiziona il nostro paese all’undicesimo posto tra i più bellicosi del mondo.
Pensate quante cose si potrebbero fare per noi e per gli altri con tutto quel denaro. Quanti investimenti, quanto micro-credito, quante iniziative per i paesi più poveri.
Il Costa Rica investe il 9,6% del Pil nella sanità pubblica, che è tra le migliori d’America, e il 7,2% nella formazione: sono percentuali nettamente superiori rispetto a quelle di quasi tutti i paesi cosiddetti “sviluppati”, compreso il nostro.
Gli abitanti del Costa Rica sono chiamati “Ticos”; un antico detto dei Ticos dice che “in Costa Rica un litigio non dura più di tre giorni”.
È una visione della vita all’insegna della pace e della serenità. Per finire non è fuori posto ricordare che per il Costa Rica il rispetto dell’ambiente e delle biodiversità è una priorità.
Nel 2021 questa nazione celebrerà il bicentenario dell’indipendenza e il regalo che i Ticos si vogliono fare per l’occasione è arrivare ad essere il primo paese al mondo a zero emissioni di carbonio: cioè al “pareggio di bilancio” tra quello che inevitabilmente l’uomo produce e la CO2 che le piante assorbono.
Il rispetto dell’ambiente è ottenuto anche dalla produzione di energia pulita: idrica, eolica, geotermica e a pannelli solari. La pace tra gli uomini e quella con la natura sono due grandi luci che il Costa Rica offre al mondo, per dire che se si vuole, a volte, si può.
(Fonte: Popoli e Missione genn 2018 pg 14-17)
PROVERBI AFRICANI
– QUANDO UN BAMBINO SBAGLIA, TUTTI HANNO SBAGLIATO.
– LE PAROLE DI UN ANZIANO NON CADONO MAI PER TERRA.
– SE NON PUOI AVERE CIÒ CHE TI PIACE, DEVE PIACERTI CIÒ CHE HAI.
– NON PUOI GIRARE IL VENTO, ALLORA GIRA LA VELA.
– DIO DÀ MOLTE COSE, MA UNA VOLTA SOLA.
– DIO CI HA DATO I SEMI DI TUTTE LE PIANTE. NOI DOBBIAMO PIANTARLI.
– LA MENZOGNA PUÒ CORRERE UN ANNO, LA VERITÀ LA RAGGIUNGE IN UN GIORNO.
– NON SI DISTINGUE L’ORMA DI UNO SCHIAVO DA UNA DI UN UOMO LIBERO.
– LE PAROLE SONO COME UOVA, APPENA SCHIUSE METTONO LE ALI.
– LA SAGGEZZA NON ABITA IN UNA SOLA CASA.
– LA BELLEZZA È MEZZO DONO DI DIO, L’INTELLIGENZA È UN DONO INTERO.
– UN SOLO SENTIERO NON È IL SENTIERO.
– L’OCCHIO DELLO STRANIERO VEDE SOLO CIÒ CHE GIÀ CONOSCE.
– QUALUNQUE PIEDE PRIMA O POI INCIAMPA.
– SE LE DITA DI UNA MANO LITIGANO, NON RACCOGLIERANNO NESSUN CIBO.
– LA BOCCA È UNA CICATRICE CHE NON GUARISCE.
– PER QUANTO SIA GRANDE UN BAOBAB, HA SEMPRE UN SEME COME GENITORE.
– L’AMICIZIA È COME LE ALGHE: QUANDO TI AVVICINI SI ALLONTANANO, QUANDO TE VAI RITORNANO.
– UN VIAGGIATORE PUÒ RACCONTARE MOLTE COSE, MA NON SPIEGARE CIÒ CHE HA VISTO.
CUBA
Lo scorso mese di aprile, come programmato già da tempo il presidente del governo e capo del partito comunista cubano, Raul Castro Ruz ha dato parte del suo potere a Miguel Diaz-Canel Bermudez: quest’ultimo è diventato presidente del consiglio dei ministri, cioè del governo, mentre Raul Castro è rimasto capo del partito.
A uno il potere decisionale (è il partito che decide) all’altro il potere esecutivo. Vedere in tutto ciò una svolta storica è forse un pò eccessivo.
È un piccolo cambiamento legato al fatto che l’establishment del partito, tutti generali dell’esercito presenti negli anni cinquanta nella Sierra Maestra a combattere per liberare il popolo cubano dalla tirannia di Batista, è un allegro consesso di ultraottantenni che si assottiglia sempre più.
Un cambiamento molto prudente, ma anche necessario. Al potere dal 1 gennaio 1959 fino al 2008 c’era stato Fidel Castro, il quale aveva lasciato per le sue precarie condizioni di salute al fratello Raul Castrò che ora compie questo ulteriore passo.
La gente di Cuba per dire che sta cambiando qualcosa senza cambiare niente, diceva scherzando che Raul Castro ha regalato a Diaz-Canel un televisore nuovo, però si è tenuto il telecomando.
Dal canto suo Raul Castro rimarrà fino al 2021 Segretario generale del PCC (partito comunista cubano), che ha Cuba rappresenta chi veramente comanda.
Inoltre il figlio di Raul, Alejandro Castro, continuerà a controllare la polizia e l’apparato repressivo sull’isola, mentre l’ex-genero di Raul, Luis Alberto Rodriguez, per ora rimane alla guida della GAE-SA, la holding militare che domina l’economia cubana.
Perchè cambi davvero qualcosa a Cuba, sopratutto in termini di libertà e diritti umani, dovrà probabilmente passare ancora molto tempo.
(Fonte: Popoli e Missione giu 2018 pg 8-11)
NIGERIA
L’organizzazione terroristica Boko Haram è attiva nel nord est della Nigeria dal 2002. Il nome ufficiale di questa organizzazione è “Jamà atu Ahlis Sunna liddà awati wal-Jihad” che significa:”Gruppo della gente della Sunna per la propaganda religiosa e la Jihad (guerra santa).”
Il fondatore è Ustaz Mohammed Yusuf (già morto ) e il capo dal 2010 è Abubakar Shekau: nasce nella città di Maiduguri, nello stato di Borno.
Boko Haram è ei soprannome e letteralmente significa: “la falsità (occidentale) è proibita (è peccato).” Dal 2015 si è alleata allo Stato Islamico (Isis).
L’idea di Yusuf è quella di instaurare la shari’a: perciò comincia fondando nella città di Maiduguri un complesso religioso che comprende una moschea e una scuola, dove le famiglie povere della Nigeria e degli stati vicini possano iscrivere i propri figli. Il centro di da ben presto altri obiettivi e comincia a lavorare per reclutare i futuri Jihadisti (perlopiù giovani) per combattere lo stato e imporre ovunque la Shari’a (legge religiosa dell’Islam).
Il gruppo include membri provenienti oltre che dalla Nigeria, anche dal Ciad e dal Niger e parla solamente arabo. Dal 2004 la sede viene spostata a Kanamma, vicino al confine con il Niger.
Yusuf attirava con successo i suoi seguaci tra i giovani disoccupati, parlando male della polizia e parlando della dilagante corruzione politica che egli imputa all’influenza culturale occidentale.
Comunque l’organizzazione resta nell’ombra fino al 2009 quando la polizia inizia delle indagini (la chiamarono “Operazione Flush”) che portarono all’arresto di alcuni appartenenti a Boko Haram e al sequestro di armi e attrezzature per fabbricare bombe.
Ciò provocò degli attacchi di vendetta da parte di Boko Haram contro la polizia e la seguente offensiva militare dell’esercito che causò almeno 700 morti e l’arresto di Yusuf, che poi morì in prigione in circostanze misteriose. A ciò sono succeduti anni di rapimenti, omicidi, attacchi a chiese e moschee, vendita di ragazze e donne come schiave e quant’altro.
C’è un dato importante da tener presente: la Nigeria ha una costituzione garante della laicità dello stato. Diciotto anni fa, però, nella parte settentrionale del paese alcuni poteri forti che avevano come obiettivo quello di minare la stabilità dello stato, riuscirono a convincere l’allora debole presidente Olusegun Obasanjo (cristiano) a introdurre la legge islamica inquella parte del paese, violando così la costituzione del paese.
Forte fu l’opposizione dei vescovi cattolici, che ricordavano a Obasanjo che nel Corano non v’è traccia di Shari’a, della quale invece si parla nella Sunna (consuetudine), il codice di comportamento trasmesso da Maometto. Da qui probabilmente è partito tutto.
(Fonte: Popoli e Missione giugno 2018 pg 11-13)
SOMALIA - KENIA ETIOPIA
Oltre ai paesi del Sahel, comprendendo la parte settentrionale del Camerun, un’altra zona che sta vivendo un forte periodo di siccità è quella compresa tra Somalia, Gibuti, Kenia, Etiopia meridionale e parte del Sud Sudan.
Si dice che in 2000 anni di storia non è mai accaduto nulla di simile. E questo perdura da circa 40 anni con ondate più o meno intense. La principale fonte di reddito per questa gente è l’allevamento del bestiame.
Per esempio Mariao Tede, una anziana signora, viveva lei con la sua numerosa famiglia (figli, nipoti e quant’altro) sulla riva di un ruscello ormai disseccato, allevando capre.
Ne aveva 200 e questo era sufficiente perchè tutti avessero di che vivere. Gliene sono rimaste 5. E qualcosa di simile è successo a tutti.
E allora si cerca di rubare il bestiame ad altre tribù situate in località dove c’è un po’ d’acqua, o si va a pascolare gli animali nei parchi naturali. C’è gente che per avere un po’ d’acqua da bere per la famiglia, deve camminare fino a 10 chilometri ogni giorno.
Molti sono passati dall’allevamento di bestiame alla produzione di carbone, facendo così sparire i pochi alberi presenti e desertificando ancora di più la zona.
Tra l’altro questa è una zona caratterizzata da una marcata instabilità politica, per cui siccità e carestie non fanno altro che moltiplicare le minacce alla convivenza pacifica.
Due stagioni consecutive con poco o niente di pioggia distruggono il tessuto sociale, la crescita della povertà provoca la crescita della brutalità e chi più ne paga le conseguenze normalmente sono le donne e le bambine, che rischiano violenza e sfruttamento.
Sono loro che devono affrontare viaggi sempre più lunghi per andare a cercare acqua per bere, cucinare, lavare, correndo il rischio di violenza e di abusi lungo la strada.
Tra Gibuti, Eritrea, Somalia, Etiopia, Sudan, Kenia e la vicina Uganda 17 milioni di persone potrebbero morire di fame e di stenti. In Somalia 6,2 milioni di persone hanno urgente bisogno di aiuto; in Kenia 2,7 milioni; in Etiopia gli affamati e a rischio epidemie sono 5,5 milioni.
In Sud Sudan un milione e mezzo di persone sono a rischio e 275 mila bambini sono al limite della sopravvivenza (qui il tutto è complicato dalla guerra civile).
Secondo molti studiosi tutto ciò è dovuto ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo. A questo, in media ogni 5 anni, si aggiunge un anomalo riscaldamento dell’oceano Pacifico centrale nei mesi di dicembre e di gennaio.
Questo fenomeno, chiamato El Nino, per la sua grande estensione è capace di condizionare il clima nel mondo intero: e così mentre da qualche parte abbiamo alluvioni, uragani e inondazioni, in altri luoghi siccità e carestie.
Sembra quasi che la natura stia mimando la società ingiusta creata dall’uomo, tra eccesso e miseria. Le organizzazioni umanitarie internazionali chiedono aiuto per questi popoli che vivono in condizioni di vita insostenibili e rischiano di essere dimenticati da tutti.
(Fonte: Popoli e Missione Mag 2018 pg 8-10)
IRAK
Qaraqosh, la più grande città cristiana di tutto l’Iraq, è, a 30 chilometri da Mosul, non lontana da Erbil, una delle cittadine più importanti del Kurdistan iracheno. Si trova nella piana di Ninive, culla della civiltà assira che da secoli ospita una delle comunità cristiane più antiche del mondo.
Il 7 agosto 2014 arrivano i militanti dell’Isis e per tutti coloro che non sono musulmani sunniti, l’unica via di salvezza è la fuga. In questa zona prima dell’arrivo dei terroristi vivevano circa 100 mila cristiani (caldei, siriaci e latini) e la convivenza era serena e pacifica anche con i musulmani.
Le donne, pur non soggette alle strette osservanze islamiche vivevano una vita riservata, spesso analfabete, senza poter andare al lavoro o intrattenersi con i vicini di casa.
I fuggitivi trovano rifugio nei campi profughi di Erbil, Kirkuk, Diabaga e Al Kosh. In uno di questi campi profughi la FOCSIV ha realizzato l’Hope Center, per dare la possibilità a grandi e piccoli di aspettare che passi il tempo facendo qualcosa di utile.
Così per le donne si sono organizzati corsi di formazione di estetista, cucito, inglese, informatica: ovviamente c’erano asili o doposcuola o centri ricreativi dove lasciare i propri figli piccoli o grandi. Il tutto pensato e organizzato per aiutare le familie, provenienti dai differenti paesi della regione, a superare l’isolamento e la fatica del'”esilio”.
Dopo due anni circa di follia, la gente ha potuto ritornare a casa, il più delle volte mezzo distrutta, e provare a tornare alla vita di prima. La novità più bella per loro è stata la “Casa delle donne”, aperta a Qaraqosh dalla cooperazione italiana.
Lì le donne hanno potuto continuare l’esperienza del “campo”: hanno trovato un luogo per incontrarsi, formarsi, discutere, essere ascoltate; ma hanno anche avuto l’opportunità di continuare i corsi di inglese, cucito, informatica, estetista, pasticceria e cucina. C’è uno sportello di ascolto per poter cancellare un pò alla volta i segni psicologici di sofferenze che sono entrare nel profondo. Per molte di loro, rimaste sole con i bambini avere un lavoro è una importante questione di sopravvivenza.
Nonostante gli anni trascorsi tra paura e incertezza, queste donne sono state capaci di trasformare la loro condizione, nei campi hanno assunto una certa autonomia e responsabilità che prima non avevano; la speranza è che tutto questo non vada perso, ma che, anche con l’aiuto della “Casa delle Donne”, resti una conquista anche per le generazioni a venire.
(Fonte: Popoli e Missione marzo 2018)
ALGERIA
Il governo algerino ha invitato ieri (16 Settembre) papa Francesco alla cerimonia di beatificazione dei 19 martiri uccisi in Algeria durante la guerra civile degli anni novanta del secolo scorso.
Lo ha confermato il ministro per gli Affari Religiosi, Mohamed Aissa, dichiarando che il suo governo ha inviato al Santo Padre un invito ufficiale a far visita al paese “considerando che le prossime beatificazioni nella città di Orango potrebbero essere un’opportunità”.
Solo due giorni prima, il 14 settembre, festa della Esaltazione della Santa Croce, è arrivata la notizia della beatificazione, il prossimo 8 dicembre, dei 19 martiri cristiani uccisi in Algeria durante la guerra civile che ha devastato il paese dal 1991 al 2002. Si calcola, ma di dati certi non ce ne sono, che siano stati uccisi in quegli anni tra i 150 mila e i 200 mila algerini musulmani, tra cui più di 100 imam che avevano rifiutato di piegarsi al volere e al potere degli islamisti.
Una terribile carneficina sulla quale si stagliano ancora tante ombre per quanto riguarda gli artefici di tante uccisioni. La cerimonia di beatificazione avrà luogo il prossimo 8 dicembre. Quasi subito gli islamisti individuarono negli stranieri un possibile obiettivo, invitandoli a lasciare il paese entro la fine di novembre 1993, pena la possibilità di essere uccisi. Ma nel mirino vi erano anche i rappresentanti politici e militari del potere algerino.
Nelle comunità religiose maschili e femminili appartenenti alla Chiesa cattolica e composte da persone di varia nazionalità si aprì subito un dibattito, di fronte a questa minaccia, sul da farsi: restare o andarsene. Alcuni restarono, altri se ne andarono: scelte dolorose e da non giudicare, soprattutto con il senno di poi.
Chi rimase si trovò a condividere la paura di tanti algerini, una paura quotidiana , una convivenza con la morte che poteva arrivare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. In tale contesto morirono 19 tra religiosi e religiose, tra cui il vescovo di Orano con il suo autista musulmano che chiuse la serie di uccisioni di cattolici. Tra i 19 ci sono i monaci cistercensi di Thibirine.
Uno potrebbe chiedersi perchè saranno dichiarati martiri se la persecuzione non fu direttamente rivolta contro la chiesa ma contro gli stranieri. Lo sono perchè fedeli a un popolo perseguitato, con il desiderio di condividerne il destino. Non pochi di essi morirono andando o tornando dalla celebrazione eucaristica celebrando quell’incontro con il Signore che è morto per restare vicino al suo popolo. (Fonte: dalle notizie di Asia news)
MONDO
Nel 2001 la Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito il 21 settembre come Giorno Internazionale della Pace, con l’obiettivo di rafforzare gli ideali di pace tanto tra tutte le nazioni e tutti i popoli, come tra i membri di uno stesso popolo. Ricordando tale ricorrenza Papa Francesco ha inviato un twitter a tutti.
In esso si richiama a ciò che aveva detto in occasione della Giornata mondiale della Pace celebrata il 1 gennaio 2018, quando segnalava che “la pace è un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, specialmente di quelli che più soffrono per la sua assenza e che tengo presenti nel ricordo e nella preghiera”. Già a gennaio il Papa aveva dedicato il suo messaggio a migranti e rifugiati. In tal senso ha criticato il fatto che in molti luoghi si sia diffusa una retorica anti-migranti e anti-rifugiati per raccogliere consensi politici.
“In molti paesi di arrivo ai è ampiamente diffusa una retorica che enfatizza i rischi per la sicurezza nazionale e i costi dell’accoglienza di quelli che arrivano, disprezzando così la dignità umana che va riconosciuta ad ogni uomo in quanto sono figli e figlie di Dio.”
Nel suo messaggio papa Francesco ha ricordato le parole di San Giovanni Paolo II: “Se sono in molti quelli che condividono il sogno di un mondo in pace e se si valorizza l’apporto dei migranti e dei rifugiati, l’umanità può trasformarsi sempre più nella famiglia di tutti, e la nostra terra in una vera ‘casa comune’.”
Nell’udienza generale del giorno prima papa Francesco affermava che “viviamo tempi in cui sembrano riavvivarsi e diffondersi sentimenti che molti considerano superati… Sentimenti di sospetto, di paura, disprezzo e addirittura di odio di fronte a individui e gruppi considerati differenti a causa dell’origine etnica, nazionale e religiosa e, come tali, considerati non sufficientemente degni di partecipare pienamente alla vita sociale.
Questi sentimenti con troppa frequenza, ispirano veri atti di intolleranza, discriminazione e esclusione che danneggiano gravemente la dignità delle persone coinvolte e i loro diritti fondamentali, incluso lo stesso diritto alla vita, alla integrità fisica e morale. La gravità di questi fenomeni non può lasciarci indifferenti. Tutti siamo chiamati a coltivare e promuovere il rispetto della dignità umana… nei diversi contesti in cui viviamo”.
(Fonte – Agenzia Aci Prensa)
IL POPOLO ROHINGYA
I Rohingya sono una minoranza etnica musulmana che da quasi 2 secoli (secondo alcuni da molto più tempo) vive in Birmania, l’attuale Myanmar (buddista al 90%). Fino al 2017 quasi due milioni di loro vivevano nel paese, la maggior parte nello stato costiero occidentale di Rakhine, dove costituivano circa un terzo della popolazione.
Il Myanmar rifiuta di riconoscere i Rohingya come cittadini, sostenendo che sono di fatto originari del Bangladesh o del Bengala. Molti arrivarono come lavoratori durante il periodo coloniale britannico, tra il 1824 e il 1948, quando il Myanmar era considerato una provincia dell’India britannica e gli inglesi si servirono dei Rohingya per contrastare i birmani.
Molti Rohingya, tuttavia, sostengono di essere discendenti di commercianti musulmani le cui origini risalgono al IX secolo. Quando il Myanmar ottenne l’indipendenza nel 1948, ai Rohingya fu permesso di richiedere dei documenti d’identità e l’accesso ad alcuni diritti e seggi in Parlamento.
Ma dopo il colpo di stato militare del 1962, i Rohingya persero questo status e furono considerati stranieri. Nel 1982 gli fu concesso nuovamente di richiedere la cittadinanza birmana a patto che fossero in grado di parlare una lingua ufficialmente riconosciuta dallo stato e possedere delle prove riguardo alla presenza della loro famiglia nel paese prima dell’indipendenza dall’impero britannico.
Alla maggior parte dei Rohingya non sono mai stati concessi documenti per dimostrare le proprie radici rendendoli di fatto apolidi. Fin dagli anni ’70, ma più intensamente dal 2011, quando il governo birmano da militare è tornato ad essere civile, i Rohingya subiscono repressioni e violenze.
La giunta militare che ha governato la Birmania per mezzo secolo ha fatto affidamento su un mix di nazionalismo birmano e buddismo theravada per rafforzare il suo dominio, e, a parere di esperti governativi degli Stati Uniti, discriminando le minoranze come i Rohingya.
Attualmente questi non hanno accesso alle stesse risorse e servizi che i cittadini buddisti hanno in Myanmar. Non gli è permesso di lasciare i loro insediamenti nella regione del Rakhine senza approvazione del governo e molti vivono in condizioni di povertà estrema.
Tra l’altro non gli è concesso possedere terreni. Dopo la ulteriore crisi del 2017 molti Rohingya vivono da sfollati in altri stati dopo esser scappati dalle violenze perpetrate dalle forze di sicurezza del paese, ma anche da altri gruppi etnici della regione, in particolar modo buddisti. L’Onu e diverse Ong hanno accusato a lungo il governo birmano di pulizia etnica attraverso politiche repressive.
Delle comunità di rifugiati Rohingya vivono anche in Bangladesh e in Malesia, dove lavorano illegalmente. Come già detto, nell’estate del 2017 la violenza è tornata a divampare nella regione. In seguito ad attacchi a stazioni di polizia effettuati dall’Arakan Rohingya Salvation Army l’esercito birmano ha reagìto con violenti rastrellamenti che hanno spinto circa 300mila Rohingya a cercare rifugio in Bangladesh.
Sono almeno 214 i villaggi bruciati in Birmania da fine agosto 2017. Attualmente nei campi profughi del Bangladesh si calcola ci siano quasi un milione di appartenenti al popolo Rohingya: siamo di fronte ad una migrazione forzosa che resta sospesa tra il rischio di genocidio e l’esilio. La domanda che molti si fanno è: “Ci sarà una nuova patria per i Rohingya?” Papa Francesco nel viaggio apostolico in Bangladesh dello scorso dicembre ha voluto parlare con un gruppo di persone (16) rohingya: “Noi tutti vi siamo vicini.
E’ poco quello che possiamo fare perchè la vostra tragedia è molto dura e grande, ma vi diamo spazio nel cuore. A nome di tutti quelli che vi hanno perseguitato, che vi hanno fatto del male, chiedo perdono. Tanti di voi mi avete detto del cuore grande del Bangladesh che vi ha accolto.
Mi appello al vostro cuore grande perchè sia capace di accordarci il perdono che chiediamo. Nella tradizione giudaico-cristiana Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza.
Tutti noi siamo questa immagine. Anche questi fratelli e sorelle sono l’immagine del Dio vivente. Una tradizione della vostra religione dice che Dio ha preso dell’acqua e vi ha versato del sale, l’anima degli uomini. Noi tutti portiamo il sale di Dio dentro, anche questi fratelli e sorelle.
Facciamo vedere al mondo cosa fa l’egoismo con l’immagine di Dio. Continuiamo a stare vicino a loro perchè siano riconosciuti i loro diritti. Non chiudiamo il cuore, non guardiamo da un’altra parte. La presenza di Dio oggi si chiama anche Rohingya. Ognuno ha la sua risposta”.
(Fonte – ACI prensa e Avvenire)
PAPUA NUOVA GUINEA (Land Grabbing)
Papua Nuova Guinea è uno stato dell’Oceania, appartiene al Commonwealth. È costituita dalla parte orientale dell’isola della Nuova Guinea e da più di 600 isole. È il territorio più povero del continente Oceania.
L’agricoltura si basa sulle esportazioni di caffè, cacao e olio di palma mentre un’altra fonte di reddito è l’esportazione del legname. Altre esportazioni che in questi ultimi anni stanno assumendo sempre maggiore importanza, sono quelle dell’oro e del rame. Molto fragile il tessuto sociale esposto alle continue fluttuazioni dovute al movimento delle multinazionali, che non si preoccupano degli squilibri economici e sociali provocati dal loro andirivieni.
Questa terra è un tesoro straordinario di biodiversità: possiede la terza foresta pluviale più grande del mondo, in cui vivono centinaia di comunità umane, nonché fauna e flora delle specie più diverse. In questo “paradiso” si è scatenata una vera e propria corsa per l’appropriazione delle terre e lo sfruttamento delle foreste.
La maggior parte del legname finisce in Cina e le imprese che ci lavorano ci guadagnano due volte: la prima con il legname proveniente dalla deforestazione, poi piantando gli alberi di palma per produrre olio di palma.
Da queste parti inoltre, non è difficile appropriarsi della terra dato che il 97% della terra era di proprietà comune, controllata dai gruppi tribali ai quali è facile portarla via. Adesso molta di questa terra è nelle mani di imprese multinazionali private: questa pratica, comune anche a altre parti del mondo viene chiamata “Land Grabbing” (appropriazione della terra).
A partire dall’agosto 2015, l’arcivescovo di Rabaul, mons Francesco Panfilo, nella provincia di Nuova Britania Orientale (nell’est del paese), ha cominciato a riflettere con la sua gente su come mettere in pratica la Laudato Sì, l’enciclica sul creato che papa Francesco aveva pubblicato nel giugno dello stesso anno.
Come frutto delle riflessioni ha pubblicato una lettera pastorale in cui ha annunciato l’impegno della Chiesa in tre ambiti: la difesa del diritto alla terra delle comunità locali, la costruzione di case per famiglie povere e la sensibilizzazione circa un progetto di coltivazione di palma di olio nel Pomio da parte di una compagnia malese che stava portando via la foresta alla gente.
Un giorno in visita in questa zona il vescovo venne avvicinato da una madre che gli chiese:”Che futuro c’è per noi?” Al vescovo sembrava di sentire le parole della Laudato sii dove papa Francesco chiede: ” Che mondo lasciamo ai nostri figli?”
Per realizzare questi obiettivi e soprattutto per trattare con la compagnia malese Rimbunan Hijau, la diocesi si è avvalsa della collaborazione di un laico neo-zelandese, l’avvocato Douglas Tennent, missionario anglicano che dopo una lunga storia di collaborazione con la Chiesa cattolica si convertì al cattolicesimo, il quale dopo alcuni mesi di lavoro, nel giugno 2017 si è visto recapitare dall’ufficio immigrazione del governo un’ingiunzione a lasciare immediatamente il paese e la revoca del permesso di poter entrare nuovamente in Papua Nuova Guinea.
La dura posizione della diocesi e il clamore internazionale suscitato dagli eventi fece si che a Tennent venisse ridato il permesso di poter rientrare e sta continuando a trattare con i malesi per il rispetto del territorio e delle popolazioni indigene. Così si esprime questo coraggioso missionario laico: “Per me le due encicliche chiave della Chiesa cattolica sono la Pacem in terris e la Laudato si.
Sono state una risposta a problemi precisi: per Giovanni XXIII il rischio di guerra nucleare, in seguito alla crisi dei missili a Cuba; per Francesco la crisi del clima. Per questo sono documenti così efficaci. Perchè rispondono a un’emergenza evidente e planetaria. Sono teologici, ma anche pratici e contestuali.”
(Fonte – MeM giu-lug 2018 pp 6-10)
YEMEN
La guerra in Yemen è cominciata nel 2015. È una guerra per procura che vede impegnati alcuni paesi africani al soldo dell’Arabia Saudita.
Di fatto lo Yemen è divenuto il terreno di scontro a distanza tra Arabia Saudita (sunniti) e Iran (sciiti). Lo Yemen condivide con Gibuti uno dei punti di collegamento più strategici del pianeta: lo stretto di Bab-el-Mandeb dal quale passano ogni giorno numerose navi porta-container e petroliere.
La cosa deve essere sembrata molto interessante a Egitto, Sudan, Marocco e Senegal che hanno prontamente risposto all’appello di Riyadh per soffocare la ribellione degli huthi (guarda caso proprio gli “odiati sciiti” sostenuti dall’Iran) insieme alla coalizione araba dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, comprendente Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait, Qatar ai quali si è unita pure la Giordania.
Si trattava di ristabilire al potere a Sana’a, capitale dello Yemen il deposto presidente Abdrab-buh Mansour Hadi per impedire all’Iran di aumentare la sua influenza sulla zona.
Inoltre, grazie ai petrodollari che a Riyadh non mancano, è stato sufficiente promettere aiuti in infrastrutture e investimenti economici per avere il supporto logistico di Gibuti, Eritrea e Somalia.
Quella che doveva essere una guerra lampo rivela però di non essere tale. Diecimila morti, milioni di sfollati, gente che muore di fame e di malattie (a causa dell’assenza di farmaci), Al-Qaida e Isis che approfittando della confusione cominciano a guadagnare terreno nel martoriato paese: la situazione si fa sempre più complicata. E così qualcuno comincia a chiamarsi fuori dal gioco: così faranno il Qatar, poi gli Emirati Arabi Uniti, poi il Marocco. In gioco ci resta l’Egitto legato da troppe questioni e interessi all’Arabia Saudita.
Dal canto suo Al-Sisi presidente yemenita ha dato all’egiziano Abbas Kamel, capo del servizio di intelligence militare egiziano il compito di occuparsi dell’addestramento delle truppe me anche di pensare a come sarà lo Yemen dopo questa assurda guerra.
Non è un mistero per nessuno che questa sia anche una guerra di mercenari: non avendo Arabia Saudita ed Emirati Arabi un esercito proprio, oltre all’aiuto degli eserciti delle nazioni africane, cui abbiamo fatto cenno, fanno affidamento anche a soldati mercenari.
Vengono soprattutto dal Darfur, Somalia, Senegal, Uganda, Ciad, Kenia ed Eritrea, attratti dalle favorevoli condizioni di ingaggio: la paga è di circa 2.800 dollari al mese, contro i 400 che prendono in genere i soldati degli eserciti regolari presenti. Addestrati nel governatorato di Taiz, Yemen sud-occidentale, dal nipote dell’ex presidente yemenita Ali Abdullah Saleh ucciso dagli huthi nel dicembre 2017.
Nel dossier “Se è ancora vivo lo sa solo Dio”, Amnesty International, denuncia la crudeltà di questi mercenari senza scrupolo – torture, esecuzioni sommarie e una serie infinita di altri crimini di guerra – e la stessa organizzazione araba per i diritti umani sta mettendo Abu Dhabi sotto i riflettori. Dall’altro lato sembra che anche l’Iran non sia da meno.
Tutto questo da molto a pensare: che con il denaro si possa comprare tutto e soprattutto dei poveri disperati che, a loro volta non fanno altro che generare nuova disperazione.
(Fonte – Nigrizia sett 2018 pp38-41)
MIGRAZIONI AL CONTRARIO
Siamo sempre più convinti di essere una terra promessa ambita da migliaia di migranti in cerca di fortuna e pronti a mettere in pericolo le nostre tranquille esistenze.
Così mentre Roma, e non solo, decide di chiudere i porti alle navi provenienti dal Mediterraneo, irrigidisce le procedure per l’ottenimento dei visti, e rende più fluide le espulsioni, sempre più giovani italiani guardano al continente africano come a un territorio pieno di opportunità.
In Ghana, per esempio, ne sono registrati 714 all’anagrafe consolare, ma molti non si fanno registrare. In tutta l’Africa, a fine 2016 (ultimo dato disponibile) iscritti all’anagrafe erano circa 72.000 italiani. E sono molte le aziende interessate ad affacciarsi a questo nuovo “mercato”, cosa che potrebbe favorire non poco la crescita di questo continente dal quale si continuano a portar via materie prime, senza apportare ricchezza ai popoli, in quanto che tutta l’industria manifatturiera è all’estero.
C’è anche un sito interamente dedicato alle opportunità che offre l’Africa lanciato da Martino Ghielmi che dice: “Frequentando il continente mi sono reso conto di come stesse sempre più crescendo una tipologia di “migrante” italiano che usciva dagli stereotipi a cui siamo sempre stati abituati.
Quando pensiamo agli italiani in Africa, la mente va subito ai missionari, al personale delle ong, ai dipendenti delle grandi multinazionali come Eni o Salini-Impregilo, che effettivamente rappresentano ancora oggi le tipologie più rappresentative. Ma accanto a queste figure iniziavo a vedere piccoli imprenditori che hanno dato vita a partnership con imprese locali, lavoratori di grandi aziende che decidono di mettersi in proprio, magari dopo aver sposato persone del posto.
Oppure giovani che lasciano tutto e partono per lanciare un’azienda o inseguendo una carriera creativa”. Insomma: non ci sono solo africani migranti economici in Italia, ma anche italiani migranti economici in Africa.
I rischi sono sempre all’angolo, e avviare un’attività non è facile, come non lo è in nessuna parte del mondo. Per uno che ci riesce ce ne sono sempre 3 o4 che falliscono. Inoltre le ambasciate italiane e le Camere di commercio non garantiscono quel sostegno che viene garantito da altri paesi alla loro gente.
Vi è poi una migrazione circolare, ovvero di africani residenti in Italia o i loro figli, che, dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana, decidono di tornare nei paesi d’origine per creare occasioni di lavoro. Le opportunità pare siano davvero molte e questo in un continente segnato da crisi, fame e guerre, ma che molti si ostinano a definire come il continente del domani.
(Fonte – Nigrizia sett 2018 pg 56-61)
CUBA
Cuba, come tutto il Caribe è una zona esposta al passaggio degli uragani. La stagione ciclonica comincia ufficialmente il primo di giugno e termina il 30 novembre. I cicloni o uragani (nella zona del pacifico si chiamano tifoni) più violenti e pericolosi si registrano tra settembre e ottobre.
Pochi giorni fa (8-9 ottobre) è passato l’uragano Michael che ha colpito la parte più occidentale dell’isola (la regione di Pinar del Rio).
L’anno scorso l’8 si settembre, festa della “Virgen del Cobre”-patrona di Cuba, è passato l’uragano Irma che ha colpito piuttosto violentemente la costa nord della parte centro occidentale del paese.
L’anno prima era passato, il 4 ottobre, l’uragano Matthew che ha colpito la zona più orientale di Cuba, zona in cui sono situate le comunità missionarie di bergamaschi, nella diocesi di Guantanamo, tutte colpite, più o meno fortemente, dall’evento.
È stato un avvenimento di una gravità considerevole, sia per la forza dell’uragano (categoria 4 e 5), sia per il fatto che lo stesso ha attraversato questa regione molto lentamente essendo ostacolato da un anticlicone a nord est di Cuba: un uragano normalmente passa in tre ore, mentre Matthew impiegò una decina di ore ad attraversare l’isola da sud verso nord e dirigersi poi verso le Bahamas.
Prima di flagellare Cuba l’uragano era passato per Haiti mietendo centinaia di vittime (tra 800 e 1000 persone).
I danni a Cuba sono stati ingentissimi sia per la natura che per gli insediamenti umani. L’oriente di Cuba è anche la zona più povera dell’isola e molte case sono in legno e mal costruite.
Migliaia di queste case sono sparite, chi non ha perso la casa ha perso il tetto e solo pochi fortunati che vivevano in case di cemento non han perso niente. Il paesaggio naturale è stato stravolto, gli alberi quasi tutti rasi al suolo, le linee elettriche e telefoniche pure.
Non ci sono state vittime direttamente imputabili al passaggio dell’uragano perchè tutti sono stati invitati a rifugiarsi in luoghi sicuri. Molti si sono rifugiati nelle grotte naturali di cui è ricca la zona costiera. Non poche persone hanno raccontato che all’uscire dalle grotte, dopo il passaggio dell’uragano, non erano più in grado di orientarsi per tornare alle loro case, tanto era stravolto il paesaggio, e una volta trovata la via non hanno più trovato la casa.
Le onde del mare superavano i 10 metri e hanno distrutto parecchie case sul lungomare di Baracoa. Ci sono stati alcuni decessi nei giorni successivi all’uragano dovuti soprattutto a infarto, per la sofferenza provocata dal vedere distrutto il poco che avevano.
Ci vorranno anni prima che si recuperi il tutto, il governo parla di almeno 5 anni. Gli interventi di primo aiuto sono stati rapidi e ben organizzati: l’esercito ha ripulito in poche settimane le macerie che avevano riempito le strade e tagliato chi alberi che pure impedivano il passaggio. Un grande grazie va ai molti governi che hanno offerto il loro aiuto e a chi, anche dall’Italia, ha dato una mano.
(Fonte – Agenzie di Stampa)
WATER GRABBING
Abbiamo già parlato di “land grabbing” in riferimento a ciò che sta avvenendo in Papua Nuova Guinea e molti altri posti del terzo mondo(come l’Amazzonia o la foresta equatoriale africana): l’accaparramento delle terre da parte di grandi multinazionali per lo sfruttamento delle foreste o delle miniere, senza regola alcuna se non il profitto. Questo avviene su vasta scala anche nella foresta dell’Amazzonia e in molte parti dell’Africa.
Così definisce il water grabbing il giornalista Emanuele Bompan:” Con il termine “water grabbing”, accaparramento dell’acqua, ci si riferisce a situazioni in cui attori potenti sono in grado di prendere il controllo o deviare a proprio vantaggio risorse idriche preziose, sottraendole a comunità locali o intere nazioni, la cui sussistenza si basa proprio su quegli stessi ecosistemi che sono depredati.
Gli effetti sono devastanti: famiglie scacciate dai loro villaggi per fare spazio a mega-dighe, privatizzazione delle fonti, controllo forzato per progetti di “agrobusiness” di larga scala, inquinamento dell’acqua per scopi industriali che beneficiano pochi e danneggiano gli ecosistemi, controllo delle fonti idriche da parte di forze militari per limitare lo sviluppo”.
Già alcuni anni fa si parlava di “oro blu” e delle guerre connesse a questa ricchezza. Le riserve di acqua dolce stanno finendo, la popolazione del mondo sta aumentando, i cambiamenti climatici, l’inquinamento e quant’altro, stanno mettendo a dura prova la vita in molte parti del pianeta.
Ogni giorno la nostra richiesta di acqua dolce oltrepassa la sua disponibilità e la vita di migliaia di persone viene messa a repentaglio. Si calcola che entro il 2030 una persona su due al mondo vivrà in zone ad elevato stress idrico.
Le guerre di Siria, sud Sudan, la tensione tra India e Pakistan avvengono in luoghi dove l’acqua è quasi assente o contesa. C’è sempre più timore che il futuro dell’umanità sia caratterizzato da tensioni geopolitiche con veri e propri conflitti tra paesi che condividono lo stesso corso d’acqua: il Nilo, per esempio è condiviso da 11 Stati, il Congo da nove, come il Rio delle Amazzoni.
Servono politiche di cooperazione e di adattamento al cambio climatico, modificando le abitudini della gente, soprattutto quelle votate allo spreco. Nel 2010 l’ONU ha adottato una risoluzione che riconosce l’acqua come diritto umano: adesso è da vedere come tutto ciò sarà reso concreto a livello giuridico.
(Fonte – MeM maggio 2018 pg 20-21 )
PERÙ
Uno dei fenomeni tipici del secolo scorso, e che continua anche in questo, soprattutto nei paesi del sud del mondo è la forte tendenza dei popoli a lasciare le campagne per concentrarsi nelle città, creando immense periferie dove violenza e degrado la fanno da padroni. Sono quelle periferie del mondo nelle quali papa Francesco ci invita ad essere presenti.
Così lo fa, per esempio il gesuita Josè Ignacio Mantecon (per tutti è Chiqui) settantenne, di esile corporatura, nelle periferie povere della parte est di Lima. La presenza dei gesuiti in queste zone risale al 1968, quando qui aprirono una parrocchia e si mescolarono di fatto alle lotte popolari per terra, acqua e servizi primari.
Erano i tempi dopo il Concilio e l’America Latina era tutta in fermento in vista della traduzione pratica delle indicazioni conciliari. Così descrive la situazione padre Chiqui:”Sono tre, come i vertici di un triangolo, le dimensioni di vita di questa gente: scuola, famiglia e strada.
In esse si svolge tutta la vita di un bambino o di un ragazzo di periferia. Molti bambini e ragazzi hanno alle spalle famiglie con pesanti situazioni di abuso o di violenza; spesso coinvolte nel traffico di droga e, non poche volte con il padre in carcere.
Quando questi bambini vanno a scuola cominciano ad avere problemi scolastici. Le scuole che si possono permettere non sono attrezzate per seguire ragazzi come loro, non hanno, ad esempio, uno psicologo. E allora cosa fanno: o cominciano a disertare la scuola o vengono direttamente espulsi perché sono bambini “cattivi”.
Dove finiscono? In strada!” Ed è proprio qui che padre Chiqui ha deciso di passare la maggior parte del suo tempo, in strada, dove vivono gli scarti del sistema; poi in mezzo ai “pandilleros”(appartenenti a pandillas, ovvero bande cittadine dedite alla malavita) , al mondo della violenza giovanile.
Lui stesso, come provocazione, fondò una associazione di pandilleros con i giovani che gli si avvicinavano fuggendo da altre pandillas per il timore di perdere la loro vita; l’associazione si chiamava “Martin Luther King”. Con padre Chiqui molti giovani decisero di cambiar vita, di mettersi al servizio del quartiere, di essere protagonisti di una stagione migliore per il loro barrio (quartiere povero).
Hanno creato un club che coinvolge 300 tra bambini e ragazzi, dove si fa sport ma anche si ripassano materie scolastiche. Lo stesso Chiqui ricorda: “Vedendo quello che si faceva qui mi chiamavano da altre bande per formare associazioni analoghe. Questo ruppe la logica di violenza che vigeva nel distretto.
” E ancora: ” Una delle cose che mi ha cambiato la vita è intendere le relazioni umane con una carica molto forte di compassione. Sono spesso stato accusato di essere “buonista”, di accettare tutti anche se non cambiano, anche se deludono le attese. A me non importa, mi basta provare a condividere i loro trascorsi e sapere che l’importante è stare con loro.
C’è una cosa che la società di oggi incentiva ovunque: la competitività, il risultato, l’eccellenza. Io credo che l’importante non sia tanto il risultato quanto la fedeltà”.
Il padre non è del tutto ottimista rispetto al futuro: la gente di questi “barrios” ha conosciuto negli anni passati la violenza del gruppo terroristico maoista “Sendero Luminoso”, poi quella repressiva dei militari. Tutto ciò ha creato un clima sociale di pesante sfiducia che non sarà facile recuperare.
Inoltre la direzione in cui va il mondo non è per niente interessante: la politica si è sottomessa alle ragioni dell’economia e della finanza, dimenticando quelle dell’uomo e dell’ambiente.
La comunicazione digitale appiattisce e omologa la cultura e i gruppi sociali. Si tratta di costruire visioni differenti e lo si può fare proprio partendo da bambini e ragazzi. La via per cambiare il mondo sono l’educazione, lo sport, il lavoro, la musica: per di qua siamo chiamati ad andare e con tutte le persone di buona volontà costruire spazi di “Regno” che offrano vere alternative agli uomini del nostro tempo.
(Fonte – MeM maggio 2018 pg 32-34)
ISRAELE – PALESTINA
Quasi ogni giorno le cronache parlano degli scontri tra ebrei e palestinesi: una guerra senza fine che pone continuamente a rischio i precari equilibri di questa zona ed anche del mondo intero.
Eppure c’è qualcuno che ha pensato che le cose potrebbero andare anche diversamente. Si chiama Bruno Hussar, un padre domenicano vissuto dal 1911 al 1996. Così si presentava: “Sono un prete cattolico, sono ebreo; sono un cittadino israeliano, sono nato in Egitto: porto quindi in me quattro identità”.
È stato lui, all’inizio degli anni settanta, il primo ad andare a vivere su un terreno messo a disposizione dai monaci trappisti sulla strada che da Gerusalemme va a Tel Aviv, per realizzare il sogno del profeta Isaia, che era anche il suo, e, forse, quello di tutti; “Il mio popolo dimorerà in una dimora di pace” (Is. 32,18). Dimora di pace in ebraico è “Neve Shalom” e in arabo “Wahat al Salam”.
E questo sarà il nome dato a questo luogo dove insieme vivono arabi ed ebrei: Neve Shalom Wahat al Salam. Padre Bruno voleva porre un segno che parlasse in un altro modo di quella terra contesa. Tutto comincia nel 72, con l’aiuto della francese Anne Le Meignen, in condizioni di povertà estrema.
Furono necessari anni di incontri con amici ebrei ed arabi per convincerli a non vivere questo luogo solo per qualche incontro nel weekend, ma a costruirci un villaggio dove poter vivere insieme. Dagli anni ottanta il sogno si trasformò in realtà: sessanta famiglie, trenta israeliane e trenta arabe che vivono insieme in condizioni di parità.
“Perchè solo se ci si mette sullo stesso piano si capisce che il problema dell’altro è anche mio”.
In tutta la storia, la scuola avrà un’importanza fondamentale: come educare i ragazzi in un contesto dove è tra i banchi di scuola che si inizia a dividersi rigidamente su base identitaria? Nasce così nel 1984 una scuola bilingue e binazionale che ha lo stesso nome del villaggio, dove ragazzi ebrei e palestinesi imparano a crescere insieme incontrandosi quotidianamente senza rinnegare la propria storia e cultura, ma mettendola in gioco nel dialogo con l’altro. La scuola oggi è frequentata da duecentoventi bambini che vengono anche da fuori.
Altra iniziativa è stata la “Scuola per la pace”, giornate di incontri e seminari che hanno visto, nel tempo , la partecipazione di migliaia di persone desiderose di trovare uno sbocco alla situazione medio-orientale.
Così si esprime Soulima Boulos, medico arabo, in un libro dal titolo “Il folle sogno di Neve Shalom Wahat al Salam” curato da Brunetto Salvarani: “Il villaggio non mi ha aiutato a risolvere la mia confusione identitaria, ma mi ha fatto capire in primo luogo che siamo tutti esseri umani con la medesima anatomia e le stesse debolezze, e che dobbiamo imparare a vivere insieme in pace, al di là di tutte le barriere che abbiamo nella nostra mente.
La missione di vivere insieme in pace avendo identità differenti, mentre intorno a noi l’odio viene predicato in ogni angolo della Terra Santa, non è semplice da portare avanti.
Il villaggio, inoltre, non deve far pensare che vivendo insieme i suoi membri finiscano col perdere lentamente la propria identità, ma piuttosto che la plasmeranno in nuove direzioni, così come tagliare i rami vecchi di un albero consente a quelli giovani di crescere”.
(Fonte – MeM maggio 2018 pg 36-37)
SUNNITI E SCIITI
Già da un pò di anni stiamo assistendo nel mondo musulmano al moltiplicarsi degli scontri tra le due correnti dell’islam, i sunniti e gli sciiti. Soprattutto in Medio Oriente, un potente miscuglio di religione e politica ha acuito le divisioni tra il governo sciita dell’Iran e gli stati del golfo, che hanno governi sunniti. Non poche guerre hanno alla loro radice (o hanno cavalcato) questa opposizione; la più cruenta in questo momento è quella Yemenita.
Ma cosa di preciso divide queste due correnti, e quanto è profonda la spaccatura?
La diatriba affonda le sue radici nel 632 dC, l’anno della morte del profeta Maometto, il fondatore dell’islam. Le tribù arabe che lo seguivano si divisero sulla questione di chi avrebbe dovuto ereditare quella che a tutti gli effetti era una carica sia politica che religiosa. La maggioranza dei suoi seguaci, che sarebbero in seguito divenuti noti come sunniti e che oggi rappresentano l’80 per cento dei musulmani, appoggiarono Abu Bakr, amico del profeta e padre della moglie Aisha.
Secondo gli altri, il legittimo successore andava individuato tra i consanguinei di Maometto. Sostenevano che il profeta avesse designato a succedergli Ali, suo cugino e genero, e diventarono noti come sciiti, una forma contratta dell’espressione “shiaat Ali”, i partigiani di Ali.
I sostenitori di Abu Bakr ebbero la meglio, anche se Ali governò per un breve periodo in veste di quarto califfo, il titolo conferito ai successori di Maometto. La frattura in seno all’islam si consolidò quando Hussein, figlio di Ali, fu ucciso nel 680 a Kerbala (nell’attuale Iraq) dalle truppe del califfo sunnita al potere. I governanti sunniti hanno continuato a monopolizzare il potere politico, mentre gli sciiti hanno vissuto all’ombra dello stato, cercando una guida nei loro imam, i primi dodici dei quali discendevano direttamente da Ali. Con il passare del tempo, le credenze religiose dei due gruppi cominciarono a differenziarsi.
Oggi tutti i musulmani del mondo – 1,6 miliardi di persone – concordano sul fatto che Allah sia l’unico dio e che Maometto sia il suo profeta. Osservano i cinque pilastri dell’Islam – la professione di fede, la preghiera, l’elemosina legale, il Ramadan (mese di digiuno) e il pellegrinaggio alla Mecca – e condividono un libro sacro, il Corano. Tuttavia, mentre i sunniti basano molto la loro pratica religiosa oltre che sul Corano anche sugli atti del profeta e sui suoi insegnamenti (la sunna), gli sciiti vedono nei loro leader religiosi, gli ayatollah, un riflesso di Dio sulla Terra.
Inoltre gli sciiti ai 5 pilastri condivisi con i sunniti, aggiungono altre osservanze, come per esempio l’amore per il bene, l’odio per il male. I sunniti non hanno clero: l’iman è colui che guida la preghiera. Gli sciiti hanno un clero organizzato, preparato in specifiche università islamiche.
Questo ha indotto i sunniti ad accusare gli sciiti di eresia, mentre gli sciiti sottolineano come il dogmatismo sunnita abbia dato vita a sette estremiste come i puritani wahabiti. Per la maggior parte delle sette sciite è di fondamentale importanza la credenza secondo cui il dodicesimo e ultimo imam sia nascosto (ossia “in occultamento”) e che un giorno riapparirà per compiere la volontà divina. Il loro senso di emarginazione e di oppressione ha dato vita a cerimonie di lutto come la ashura, quando i fedeli sciiti in processione si flagellano per ricordare la morte di Hussein a Kerbala.
Tra sunniti e sciiti non c’è mai stato uno scontro paragonabile alla guerra dei trent’anni, che ha visto contrapposte tra loro le diverse confessioni cristiane nell’Europa del seicento e ha provocato un numero enorme di morti.
Questo è dovuto in parte alla scelta degli sciiti, consapevoli della loro condizione di minoranza, di tenere un profilo basso. Le linee che oggi dividono i musulmani in Medio Oriente sono tracciate tanto dalla politica quanto dalla religione. La “Mezzaluna sciita”, che dall’Iran passa per la Siria governata dal regime di Assad e finisce nel Libano dell’Hezbollah, un tempo era lodata da molti esponenti sunniti.
Ma le rivoluzioni in corso nella regione hanno provocato una frattura tra i governi sciiti e gli stati sunniti del golfo Persico, come Arabia Saudita e Qatar, che sostengono costantemente i loro correligionari con denaro. Questa situazione ha rafforzato l’assertività dei sunniti facendo sentire gli sciiti più minacciati che mai. Da tener presente che i vari gruppi estremisti, da Al Quaida, all’Isis, a Boko Aran e molti altri sono tutti di matrice sunnita.
(Fonte – The Economist 5 gennaio 2016 e informaze da wikipedia)
IL POPOLO CURDO
I Curdi sono una popolazione di origine iranica. La loro regione storica è il Kurdistan (“terra dei Curdi”). Il Kurdistan non ha mai formato uno Stato indipendente e attualmente è diviso tra Turchia, Iran, Iraq, Siria, Armenia e Azerbaigian. La parte più estesa del Kurdistan si trova in Turchia (30% di tutto il territori turco), dove vivono circa 13 milioni di Curdi.
Poiché il popolo curdo è diviso tra diversi Stati è difficile calcolare esattamente la sua consistenza numerica totale: la cifra oscilla, comunque, tra i 30 e i 40 milioni di persone.
Il Kurdistan è una regione montuosa dell’Asia Minore vasta circa 450 mila km , bagnata dai fiumi Tigri ed Eufrate. I Curdi che la abitano sono una popolazione antichissima e parlano una lingua della famiglia iranica. Nel 7° secolo d.C. la regione venne conquistata dagli Arabi e i Curdi si convertirono all’Islam.
Tra il 12° e il 13° secolo sarà proprio una dinastia curda a regnare in Egitto e in Siria: era nato, infatti, in un villaggio curdo il sultano Saladino, avversario dei crociati a Gerusalemme e in Palestina. Nel 16° secolo la maggior parte del Kurdistan fu inglobata nell’Impero ottomano, mentre una parte veniva conquistata dalla Persia.
Nonostante fosse stato assoggettato, il popolo curdo riuscì a mantenere una certa autonomia conservando le sue divisioni interne in tribù patriarcali e un sistema economico-sociale di tipo feudale. Nel corso dell’Ottocento iniziarono a manifestarsi le aspirazioni indipendentiste dei Curdi, ma le loro rivolte furono tutte represse dagli Ottomani.
Dopo la fine della Prima guerra mondiale, le potenze vincitrici liquidarono l’Impero ottomano sconfitto dividendo il suo vasto territorio. I Curdi sperarono che fosse arrivato per loro il momento di costruire uno Stato nazionale e indipendente: il Trattato di Sèvres del 10 agosto 1920, infatti, stabiliva il diritto all’autonomia per la popolazione curda in un ristretto territorio.
Il governo turco, però, si oppose a questa decisione e il Trattato di Losanna del 1923 annullò quanto stabilito tre anni prima riconoscendo alla Turchia il controllo del settore più ampio del Kurdistan. È di questo periodo anche l’eccidio degli armeni per mano dei turchi.
Ancora una volta, così, la terra dei Curdi veniva smembrata e divisa e nei decenni successivi si susseguirono le rivolte indipendentiste organizzate dal popolo curdo in Turchia, tutte sanguinosamente represse. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale anche i Curdi dell’Iran, dell’Iraq e della Siria si ribellarono più volte, senza successo, ai rispettivi regimi. Negli anni Ottanta, nel corso della guerra tra Iran e Iraq (1980-88), i Curdi furono vittime da entrambe le parti, ma soprattutto in Iraq, di violente rappresaglie.
Nel 1991, alla fine della Guerra del Golfo, una nuova insurrezione indipendentista scoppiata nel Kurdistan iracheno veniva soffocata nel sangue da Saddam Husain. In quell’occasione l’ONU condannò la repressione dei Curdi iracheni e aprì la strada in questo modo alla creazione di una fascia di sicurezza per il popolo curdo nel Nord dell’Iraq, una zona interdetta al volo degli aerei iracheni.
Ma le condizioni di vita dei Curdi in tutti gli Stati della regione rimanevano molto dure: discriminati e perseguitati, i Curdi non hanno il diritto di usare ufficialmente la loro lingua nazionale e in Turchia rischiano l’arresto solo per partecipare a riunioni pubbliche nella loro lingua.
Anche in Siria la persecuzione verso i Curdi è particolarmente oppressiva: ad alcune minoranze curde è negato il diritto di voto ed è proibito uscire dal paese, servire nell’esercito, essere impiegati nelle istituzioni statali e possedere una macchina o qualsiasi altro bene privato.
Nell’attuale divisione degli Stati in Medio Oriente la nascita di uno Stato autonomo del Kurdistan appare ormai un’ipotesi irrealizzabile: nessuno dei paesi coinvolti, infatti, è disposto a cedere aree più o meno ampie del suo territorio a favore del popolo curdo, privandosi delle materie prime di cui quei territori sono ricchi, prima fra tutte il petrolio.
(Fonte – Enciclopedia Treccani e wikipedia)
BOLIVIA
A dodici anni dall’inizio dell’avventura politica del MAS (Movimento al Socialismo), l’economia boliviana continua basandosi essenzialmente sull’esportazione di idrocarburi. Questo ha creato due momenti ben distinti nella gestione del governo di Evo Morales: un primo momento di abbondanza, dovuto ai prezzi elevati degli idrocarburi; un secondo momento di declino dovuto all’abbassarsi del prezzo degli stessi.
Mentre nel primo periodo si è vista una significativa riduzione della povertà e un miglioramento delle infrastrutture del paese, nel secondo, che perdura tuttora, nonostante il prezzo degli idrocarburi sia aumentato, si sono viste le debolezze dell’economia boliviana, dovute a una bassissima industrializzazione e, conseguentemente, una bassa produttività.
L’economista Josè Gabriel Espinoza fa notare come il prezzo alto degli idrocarburi unito a un basso tasso di interesse siano pilastri fondamentali per l’esecuzione del progetto politico-sociale applicato dal governo. Nel decennio delle “vacche grasse”, l’economia boliviana è cresciuta mediamente a un tasso elevato, che ha raggiunto il suo apice nel 2013, con una crescita del 6,8%.
Un altro settore che ha contribuito alla crescita è stato quello edile, che ora sta contraendosi, anche a causa di un abbassamento del prezzo delle case.
Inoltre il modello di crescita basato sull’estrazione di idrocarburi, principalmente di gas (di cui la Bolivia è ricchissima, essendo il secondo produttore mondiale), ha creato disparità entro i vari dipartimenti dello stato plurinazionale: Tarija è in recessione, Chuquisaca e Cochabamba in costante calo nella crescita.
Da parte sua il governo nella persona del ministro dell’economia Mario Guillen ha fatto presente che la crescita non è dovuta solo al settore estrattivo, ma anche e sopratutto all’agricoltura e allo sviluppo di prodotti finanziari. Aggiunse inoltre che anche settori come l’industria, i trasporti, le telecomunicazioni, l’industria manifatturiera e il commercio sono cresciuti in diverse percentuali.
Industriali e commercianti non sono d’accordo con le dichiarazioni del ministro e parlano senza mezzi termini di un calo dell’economia del paese.
Infine anche il debito estero boliviano, nonostante le forti entrate dovute all’esportazione di materie prime, è aumentato in questi ultimi anni e torna ad essere una variabile economica rilevante. L’economista Espinoza fa presente che per mantenere la stabilità economica degli ultimi 30 anni, la Bolivia deve fare alcuni cambiamenti strutturali e produttivi.
Così si esprime Espinoza:”Il basso tasso di disoccupazione, l’incremento delle infrastrutture e le variabili come il tasso di cambio e l’inflazione, devono adesso accompagnarsi a politiche che fomentino la dignità del lavoro, la produzione di beni e servizi con valore aggiunto e la crescita degli investimenti privati”.
È necessario inoltre incentivare settori come l’industria manifatturiera e l’agricoltura, prendendo misure reali contro il contrabbando e l’importazione di prodotti che il paese può benissimo produrre con forza propria.
Di certo la Bolivia in questi ultimi decenni è stato uno dei paesi dell’America Latina che più ha camminato in direzione di uno sviluppo che ha avuto ricadute positive su tutti i settori della società.
(Fonte – Quotidiano “Opinion” di Cochabamba)
EARTH OVERSHOOT DAY
Quest’anno il primo di agosto è stato l’Earth Overshoot Day (EOD) ovvero il giorno in cui abbiamo consumato tutte le risorse naturali che la terra è in grado di rigenerare in un anno; il giorno in cui iniziamo ad accumulare un debito ecologico non facile da ripagare.
E ogni anno è sempre peggio. Quarant’anni fa l’EOD era il 29 dicembre; nel 2000 si era già spostato alla fine di settembre, lo scorso anno era il 2 di agosto. Il calcolo lo fa un Istituto Internazionale di ricerca che si chiama Global Footprint Network che calcola l’impronta ecologica degli abitanti di ogni nazione.
Per impronta ecologica si intende l’area di terra necessaria per fornire a ciascuno ciò di cui ha bisogno: cibo (carne, pesce, frutta, verdura, cereali…), acqua, legname, vestiario (cotone…), lo spazio per strade e case, l’area forestale necessaria ad assorbire le emissioni di anidride carbonica di prodotte da ognuno di noi.
Il fatto è che l’umanità utilizza risorse naturali più velocemente di quanto gli ecosistemi della terra siano in grado di rigenerare. Dal 2 di agosto stiamo perciò erodendo dal capitale naturale del pianeta che dovrebbe servire anche alle generazioni future: stiamo, praticamente, rubando futuro a chi verrà dopo di noi. Così dice il direttore scientifico del WWF Italia, G. Bologna:” In pratica è come se stessimo usando 1,7 terre.
Secondo i calcoli del Global Footprint Network il nostro mondo è andato in Overshoot (sorpasso) nel 1970 e da allora il giorno del sovra-sfruttamento è caduto sempre più presto”. Ovviamente il 1 di agosto è la data che descrive la media mondiale dell’Overshoot; molto diverso è il discorso per le singole nazioni.
Per esempio il Qatar ha il suo Overshoot day il 9 febbraio, il Lussemburgo il 19 febbraio, gli Emirati arabi Uniti il 4 marzo, gli Stati Uniti il 15 marzo…e così via. Per l’Italia il giorno l’Overshoot day è il 24 maggio. Dei paesi dell’Africa solo l’Egitto rientra in questa classifica (inizio di novembre), gli altri sono tutti fuori, perché a loro la terra di sotto ai piedi gliela stiamo togliendo noi.
Meno del 25% della terra oggi è nelle sue condizioni naturali, e nel 2050 sarà circa il 10%: il resto è tutto sfruttato intensivamente dall’uomo. Non molto diversa la situazione per gli ecosistemi marini: ad oggi solo il 13,2 % di tutti gli oceani del mondo non sono stati sfruttati e si trovano perlopiù nell’emisfero meridionale e alle estreme latitudini.
Nei prossimi 30 anni, in seguito ai cambiamenti climatici 4 miliardi di persone vivranno in luoghi aridi e circa 700 milioni, saranno obbligati a emigrare. Lo sfruttamento del suolo e i cambiamenti climatici potrebbero, in alcune regioni, portare a una diminuzione del 50% di raccolti, con una conseguente mancanza di cibo per intere popolazioni. Cosa possiamo fare? – Un primo passo riguarda l’alimentazione: ridurre i consumi di carne e gli sprechi. – Costruire edifici efficienti dal punto di vista del risparmio energetico.
– Oggi siamo più di 7 miliardi, nel 2050 saremo più di 9 miliardi: nella paternità responsabile ci potrebbe stare un pensierino anche al benessere dei figli di tutta l’umanità. –
Il Carbon Footprint rappresenta il 60% dell’impronta ecologica: tagliare queste emissioni porterebbe in avanti l’Overshoot Day di tre mesi. Insomma stiamo probabilmente esagerando nei nostri consumi: fare un passo indietro farebbe bene alla terra e a chi ci vivrà nei secoli a venire.
(Fonte – Da “Informarsi” e da “Focus”)
FAME NEL MONDO
Nessuna buona notizia: si potrebbe riassumere così il contenuto del Rapporto 2018 sullo Stato della Sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo elaborato dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), dall’IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo), dall’UNICEF (Fondo per l’Infanzia), dal WFP (Programma Alimentare Mondiale) e dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
Il quadro generale dice che la fame nel mondo ha ripreso a crescere, tornando ai livelli di un decennio fa; che ai tradizionali ‘nemici’ della sicurezza alimentare rappresentati da guerre, povertà e conflitti, si è aggiunto un altro avversario di grande portata, il cambiamento climatico; che, paradossalmente, la malnutrizione produce non solo ritardi nella crescita, ma anche obesità sia infantile che da adulti, ciò dovuto al fatto che si mangia quello che si trova.
Secondo il rapporto, una persona su nove (821 milioni) nel mondo soffre ancora la fame, 150 milioni di bambini hanno ritardi nella crescita e quindi nell’apprendimento e nelle capacità richieste dagli impegni futuri e questo è definito “inaccettabile”. A fronte di queste cifre c’è la piaga dell’obesità: per i bambini di meno di cinque anni si tratta di 38 milioni in eccesso ponderale; per gli adulti la cifra arriva a 672 milioni di individui in tutto il mondo.
Su questi squilibri, che in alcune regioni del mondo sono ormai cronici, si abbattono le conseguenze terribili del cambiamento climatico con i suoi fenomeni estremi come siccità e desertificazione da una parte, inondazioni, uragani e tifoni dall’altra. Quest’anno il “focus” del rapporto si è spostato dalle guerre al clima, e da qui l’invito a tutti i paesi ad “agire rapidamente, su larga scala, adottando programmi di partenariato con finanziamenti adeguati” per la gestione dei rischi dati dalle catastrofi naturali e per accrescere “la resilienza in favore della sicurezza alimentare e della nutrizione”.
La situazione sta peggiorando in Sud America e nella maggior parte delle regioni dell’Africa, mentre la tendenza al calo della sotto-nutrizione che aveva caratterizzato l’Asia negli anni passati sembra aver rallentato in modo significativo.
Così continua il rapporto: “Se vogliamo raggiungere un mondo senza fame e malnutrizione in tutte le sue forme entro il 2030, è imperativo accelerare e aumentare gli interventi per rafforzare la capacità di recupero e adattamento dei sistemi alimentari e dei mezzi di sussistenza delle popolazioni in risposta alla variabilità climatica e agli eventi meteorologici estremi” hanno affermato i responsabili delle cinque organizzazioni delle Nazioni Unite autrici del rapporto. I cambiamenti climatici stanno già minando la produzione di importanti colture come grano, riso e mais nelle regioni tropicali e temperate e si prevede che la situazione peggiorerà con l’aumentare delle temperature.
Le analisi del rapporto mostrano che la prevalenza e il numero di persone sotto-nutrite tendono ad essere più alti nei paesi altamente esposti agli eventi climatici estremi.
Il rapporto afferma che sono stati compiuti scarsi progressi nella riduzione dei problemi della crescita infantile, con circa 151 milioni di bambini sotto i cinque anni di età con crescita ritardata a causa della malnutrizione nel 2017, rispetto ai 165 milioni del 2012. Globalmente, l’Africa e l’Asia rappresentano rispettivamente il 39% e il 55% di tutti i bambini con ritardi nella crescita. La prevalenza di deperimento infantile rimane estremamente elevata in Asia, dove quasi un bambino su dieci sotto i cinque anni ha un peso basso per la sua altezza, rispetto a solo uno su 100 in America Latina e nei Caraibi.
Il rapporto descrive come “vergognoso” il fatto che una donna su tre in età riproduttiva a livello mondiale sia affetta da anemia, che ha conseguenze significative sulla salute e sullo sviluppo sia per le donne che per i loro bambini. Nessuna regione ha mostrato un calo nell’anemia tra le donne in età riproduttiva, e la prevalenza in Africa e Asia è quasi tre volte superiore a quella ad esempio del Nord America.
Per quanto possa sembrare paradossale accanto alla fame c’è anche il problema dell’obesità che sta aumentando significativamente nei paesi ricchi, ma che sta crescendo anche in Africa e in Asia dove è dovuto perlopiù all’insicurezza alimentare e alla consumazione di cibi meno genuini.
Sappiamo già quello che si potrebbe fare per ribaltare la situazione, ma siamo ben lontani dall’attuarlo.
(Fonte – Rapporto Fao 2018 su sicurezza alimentare e nutrizione)
COSTA D'AVORIO
La Costa d’Avorio, superata la crisi politica legata alle elezioni del 2011, in questi ultimi anni sta crescendo a ritmi sostenuti, con una crescita del PIL tra l’8 e il 9%, facendo invidia a molti paesi europei. Il paese può essere, a ragione, considerata la locomotiva dell’economia dell’Africa Occidentale.
Tuttavia rimane stagnante l’indice di sviluppo umano, legato alla distribuzione delle ricchezze, alla istruzione, alla salute e a tutto ciò che può giovare al benessere della gente. Più del 40% della popolazione vive sotto la soglia della povertà, mentre il 50% dei 22 milioni di ivoriani ha meno di 35 anni di età. La Costa d’Avorio è il quarto paese per provenienza dei migranti che sbarcano sulle coste del Mediterraneo, in particolare in Italia.
L’ambasciatore italiano in Costa d’Avorio afferma: ” Il paese ha delle enormi potenzialità e l’attuale Presidente ha avuto il grande merito di rimetterlo in marcia dopo un decennio di crisi interna. Ma la sfida non è ancora stata vinta o meglio, è stata vinta solo in parte. Altri passi devono essere fatti, soprattutto dal punto di vista economico… La classe media, il vero motore di un’economia emergente, quella che genera una domanda e attiva l’offerta, è cresciuta, ma non a sufficienza”.
La metà dei soldi che circolano nella Comunità Economica dell’ Africa Occidentale, circola in Costa d’Avorio, e il 40% di tutte le merci viene esportata dal porto di Abidjan. Una grande ricchezza, quindi, ma mal distribuita. Così continua l’ambasciatore: “Il processo riformatore deve continuare attraverso politiche inclusive: redistribuzione della ricchezza, istruzione, sanità, università, formazione tecnica”.
La Costa d’Avorio è un paese ricco, è il maggior produttore ed esportatore mondiale di cacao, di anacardi, di olio di palma e il terzo di caffè. È ricco inoltre di grandi quantità di minerali: diamanti, manganese, nichel, bauxite e oro. Si stanno cercando anche giacimenti di petrolio nelle proprie acque territoriali. Tutto questo però non ha ancora avuto una ricaduta significativa sull’economia reale del paese.
Il paese ha quindi bisogno di due cose: una “economia inclusiva” quindi una migliore ripartizione delle ricchezze, e un maggior senso dello Stato. Così si esprime ancora l’ambasciatore: “Non c’è stato, perlomeno non è andato fino i fondo il processo di riconciliazione nazionale che qui è molto sentito. La gente avverte questo distacco.
Le parti che si sono fronteggiate durante la guerra civile non si sono pienamente rappacificate… Non solo. Parte della popolazione, quella che è stata sconfitta negli anni di crisi, si sente esclusa dalla gestione politica del paese e il tasso di astensionismo è elevato…. Tutto questo spiega bene una certa disillusione che pervade parte della popolazione”. Ed sono forse queste le ragioni per cui non pochi giovani decidono di andarsene dalla Costa d’Avorio.
È peraltro stato accertato che molti emigranti che dicono di venire dalla Costa d’Avorio provengono in realtà da altre parti dell’Africa. Alessandro Rabbiosi, responsabile per “Terre des Hommes Italia” in Costa d’Avorio dice:
“Una delle ragioni della fuga, oltre al richiamo dell’Eldorado europeo è l’aspetto economico, anche se non è il più rilevante. Chi tenta la via dell’Europa, lo fa spesso per mancanza di fiducia nel sistema paese in generale…
La gente, i giovani in particolare, non vedono prospettive concrete, hanno la percezione di vivere in un paese senza sbocchi concreti, incapace di soddisfare le loro ambizioni”.
Anche solo per arrivare il Libia servono tra i 1.200 e 1.300 euro, cifre che non tutti si possono permettere e nonostante ciò sono tra le 15.000 e le 16.000 le persone che ogni anno lasciano il paese.
Se le cose stanno così per un paese la cui economia tutto sommato non è tra le peggiori è facile intuire cosa succeda da tante altre parti e il perché di tanta gente che bussa alle nostre porte.
(Fonte – Agenzia Agi)