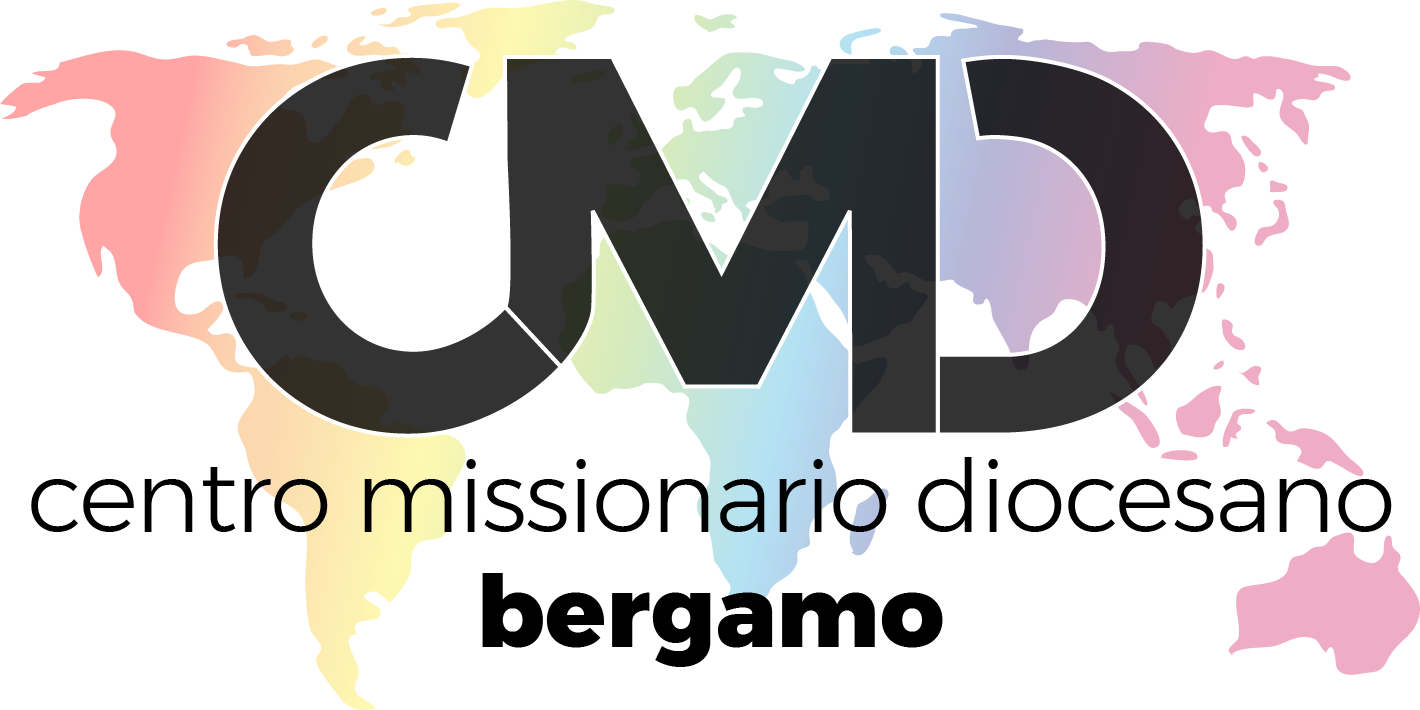Ci sembra bello e doveroso un suo ricordo, proponendo alcuni stralci della sua meditazione dal titolo “Il Dio del per-dono”: dono ricevuto e testimonianza cristiana attiva nella città e nel mondo”, tenuta nel 2014 al Convegno missionario Sacrofano (Roma), al quale partecipammo come Centro missionario con una folta delegazione, avendo anche la fortuna di scambiare alcune parole con lui sulla figura del nostro beato Sandro Dordi a cui era molto legato, (come cita all’inizio della sua meditazione).
Ad-Dio padre Gustavo!
Voglio anzitutto ringraziarvi per l’invito e per questa opportunità di condividere alcune riflessioni sulla fede e la speranza che abbiamo in comune. Voglio anche ringraziare per la presenza di tanti missionari italiani nel mio Paese, tra i quali ho molti amici. Ho conosciuto molto bene don Sandro Dordi [sacerdote Fidei Donum della diocesi di Bergamo, assassinato a Chimbote, Perù, il 25 agosto 1991, da Sendero Luminoso. Verrà beatificato il 5 dicembre 2015 prossimo a Chimbote, ndr], e sono stato molto vicino alla terribile vicenda della sua morte.
Desidero presentare il mio tema in tre punti. Il primo riguarda la nozione di evangelizzazione e la sua realtà. Il secondo esamina il significato di quello che noi chiamiamo “la povertà e la condizione dei poveri”. Il terzo punto è una piccola riflessione sulla memoria che la Chiesa deve fare della testimonianza di Gesù.
Per quanto riguarda il primo punto, vorrei cominciare commentando brevemente tre frasi.
La prima è di Paolo VI, che nell’Evangelii Nuntiandi ha detto: «La Chiesa esiste per evangelizzare» (EN 14). Possiamo capire questo punto dicendo che evangelizzare è la ragion d’essere della Chiesa; […] non si può dire che la Chiesa prima esiste e dopo evangelizza, ma esistenza e impegno per l’evangelizzazione sono una sola cosa. Se la Chiesa non evangelizza non è Chiesa, ma solo un gruppo di persone. L’evangelizzazione è una tematica molto importante nell’Evangelii Nuntiandi, la quale può guidarci nel comprendere cosa sia l’evangelizzazione.
La seconda frase è ben detta da papa Francesco: «Evangelizzare è rendere presente nel mondo il Regno di Dio» (EG 178). È semplicemente questo: avere al centro della predicazione Gesù, venuto per dire che il Regno è qui, anche se non ancora pienamente. Credo che questa definizione di evangelizzazione sia molto bella.
La terza frase viene ancora da papa Francesco: «La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Dio che abbiamo ricevuto» (EG 264). Senza amore non c’è evangelizzazione, come è detto nel Vangelo di Giovanni: dobbiamo amare come Gesù ama e ha amato. Un’altra frase dei vangeli sinottici dice: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. L’accento si pone sulla gratuità dell’amore di Dio e questo è stato molto presente nel lavoro dei missionari nel secolo XVI, soprattutto in Bartolomé De Las Casas che ripeteva: «Dobbiamo dare gratuitamente».
Come è stato detto più volte in questi giorni, c’è un documento molto interessante del Concilio, l’Ad Gentes, che parla della nozione di evangelizzazione e ha allargato il senso della missione, che precedentemente era stato ristretto. Il Concilio ha recuperato il senso globale dell’evangelizzazione e nei primi cinque capitoli di questo documento è affermata con molta chiarezza una questione che sembra teorica, ma che è molto importante: e cioè, che l’evangelizzazione della Chiesa è un prolungamento delle due missioni trinitarie, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è molto importante perché fa derivare l’evangelizzazione della Chiesa direttamente dalla Trinità e mostra che la missione della Chiesa viene da lontano e attraversa tutta la storia umana.
[…]
Credo che nel secolo passato ci sia stato un cambio nella percezione della povertà anche grazie ad un’intuizione di papa Giovanni XXIII che ne ha parlato nel settembre del 1962, un mese prima dell’inizio del Concilio. La Chiesa ha sempre ripetuto questo nei secoli, da Gesù ad oggi; nel Concilio tale tema è stato molto presente, anche se nei documenti conciliari non vi è molto spazio. Il difensore del tema della povertà è stato il cardinal Lercaro, grande personalità che ha molto insistito su questo alla fine della Prima Sessione, dicendo apertamente che “Il tema del Concilio deve essere la povertà e l’annuncio del Vangelo ai poveri. Dopo di questo possiamo parlare di tante altre cose, partendo da questo punto”. Egli fu ascoltato con molto rispetto, e questo stimolo è stato molto importante per la Chiesa latinoamericana. Medellin è una conferenza celebrata tre anni dopo la fine del Concilio e abbiamo cercato di rispondere alla preoccupazione di papa Giovanni XXIII.
Credo che questa percezione sia presente oggi e vorrei indicarne due caratteristiche. La prima caratteristica è molto importante per la riflessione teologica e per l’annuncio del Vangelo, ed è che la povertà è una realtà molto complessa. Di solito, si pensa subito all’aspetto economico del problema, e questo è vero; è un aspetto molto importante, ma non l’unico. È cambiato il modo di leggere questa complessità perché sono state messe in luce altre caratteristiche della povertà legate all’aspetto culturale, razziale, di genere. Ciò comporta un’interpretazione più estesa e profonda di quello che chiamiamo povertà, ricordando una frase di un poeta francese, Verlaine, che diceva: “Quello che è più profondo nell’essere umano è la pelle”. Certamente si tratta di un paradosso perché la pelle è la superficie esterna del corpo, ma è molto importante perché il suo colore è assai rilevante quando si parla di povertà: ci sono tanti motivi legati alla differenza di razza. Anche la condizione femminile è spesso una condizione di povertà, sebbene ontologicamente non sia povertà, ma socialmente lo è. L’appartenenza ad una cultura non occidentale è una condizione di povertà che è multidimensionale, una realtà di cui l’evangelizzazione deve tenere conto. Questa complessità è stata presente nella conferenza di Medellin. Non voglio sminuire l’importanza del fattore economico, ma la povertà è qualcosa di più ampio.
L’altra caratteristica che vorrei anche ricordare, è quella delle cause della povertà. Per molto tempo l’umanità e la Chiesa hanno accettato la povertà come un fatto naturale, quasi una fatalità. Certe persone venivano al mondo ricche, altre povere, come un fatto naturale. Certamente non è così. La povertà nella sua complessità è una creazione nostra, di noi esseri umani, noi facciamo e abbiamo fatto la povertà, perciò se le cose stanno così dobbiamo vedere che la solidarietà con i poveri, la lotta contro la povertà non è una questione puramente economica ma è una questione di mentalità: la mentalità della superiorità maschile sulla realtà femminile è una categoria mentale – certamente falsa – che dobbiamo cercare di cambiare. Vivere la solidarietà con il povero non è soltanto aiutare queste persone, ma lottare contro le cause di questa condizione.
[…]
Vorrei ricordare un secondo punto, il significato biblico della povertà. A mio parere, abbiamo tre modi di comprendere e di parlare della povertà: uno, certamente molto presente nella Bibbia, la povertà materiale, preferirei dire “reale”. È una povertà scandalosa. Dopo il Concilio, in America Latina, la riflessione teologica si è centrata sullo scandalo della presenza di una terribile povertà in un continente anche oggi certamente considerato cristiano. E’ l’aspetto più rilevante della povertà.
L’altro modo è quello della povertà spirituale. C’è qualche confusione intorno a questo tipo di povertà. È un’espressione metaforica: la povertà reale viene usata per definire quella spirituale. Ma per questo c’è un’altra metafora più adatta: quella dell’infanzia spirituale. Un ottantenne può avere un’infanzia spirituale… Ciò significa mettere la nostra vita nelle mani di Dio. Perciò è chiamata povera: è il nostro confidare in lui. Il povero spirituale è il discepolo, o meglio, il santo. Quando parliamo dell’opzione preferenziale per i poveri, parliamo dei poveri reali, non dei poveri spirituali. Questi ultimi sono pochi, veramente. Fare “l’opzione per i santi” è molto facile: l’opzione per questa gente sofferente, invece, no. La povertà spirituale si può leggere nelle Beatitudini di Matteo quando dice “beati”, “felici i poveri spirituali”, i discepoli che mettono la loro vita nelle mani di Dio. Ciò non avviene in un giorno; è un cammino. Qualcuno parla anche del povero spirituale come dell’ignorante, del peccatore: la Bibbia non dice mai che il peccatore è un povero spirituale… La povertà spirituale è la santità.
Conseguenza di questo è la terza nozione di povertà: la povertà volontaria, presente nella Bibbia e nel messaggio di Gesù. Viene dalla povertà reale, perché la solidarietà con i poveri reali chiama ad essere come loro povero reale, vivendo le difficoltà che nella vita vivono i poveri reali; per esempio, l’arcivescovo Romero ha scelto una povertà volontaria, a fianco dei poveri del suo Paese. Ha ricevuto critiche (e non solo) da molti. Vi è anche povertà spirituale, in quella volontaria: come mettere la nostra vita nelle mani di Dio, se abbiamo altri dei? La povertà volontaria esige poi una certa povertà materiale: non possiamo solo dire di imitare la vita dei poveri. Il povero appare insignificante: se la nostra società non accetta questo, se non lo consente, non possiamo dire di sentirci in solidarietà con i poveri. E’ quello che ha fatto Romero, e perciò è stato assassinato. La sua povertà volontaria ha incontrato resistenza in altre persone. Un filosofo francese protestante, Paul Ricoeur, diceva che non siamo veramente con i poveri se non siamo contro la povertà: essere contro la povertà è una maniera di essere con i poveri.
Per finire, sulla povertà, direi questo: la povertà in ultima analisi significa morte. Morte fisica e culturale. I missionari del secolo XVI avevano questa espressione: “Gli indigeni stanno morendo prima del loro tempo”. Questo accade oggi, per i poveri dell’umanità. La gente muore ancora per le malattie. Credo che la povertà sia questo, anche dal punto di vista culturale. Se noi non valorizziamo una cultura, in un certo modo uccidiamo le persone che vi appartengono: è una questione molto importante. Questa maniera di vedere la povertà ha condotto all’opzione preferenziale per i poveri. Vorrei enfatizzare un solo punto: diciamo “preferenziale”, perché vogliamo sottolineare che l’amore di Dio è per tutte le persone, è universale, senza distinzione, e allo stesso tempo va prima ai poveri reali, perciò diciamo preferenziale […]
Dal momento che non sono solo i poveri che devono ricevere il nostro amore, non è facile per noi comprendere l’opzione per gli ultimi di questo mondo
[…]
Passiamo al terzo punto: la memoria. La memoria è un tema molto importante nella Bibbia. “Ricorda, Israele…”, è un’espressione molto frequente. Vorrei dire che noi cristiani abbiamo e dobbiamo vivere due memorie. Una è la memoria – che conosciamo benissimo – dell’Ultima Cena.
Nell’Ultima Cena, Gesù dice: “Fate questo in memoria di me”; non dice soltanto di cenare, ma di fare “memoria” di me; un ricordo, una memoria della vita, dell’insegnamento, della passione, morte e resurrezione di Gesù. Tutto questo per dare, per esprimere la nostra gratitudine, per ringraziare: è questa l’Eucaristia.
L’altra memoria invece si trova nel vangelo di Giovanni ed è la lavanda dei piedi.
Nel vangelo di Giovanni non abbiamo la narrazione dell’istituzione dell’Eucaristia; si può dire che il racconto della lavanda dei piedi, sostituisce quello dell’istituzione dell’Eucaristia. Gesù lava i piedi dei discepoli e dice “Vi ho dato l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi”, in servizio umile per gli altri. La simbologia della lavanda dei piedi è accogliere la persona, è dirle: “Tu qui sei un bene”. Abbiamo queste due memorie e non possiamo fare la scelta di una sola di queste memorie, perché entrambe sono legate. Eucaristia e fare qualcosa per le altre persone, sono una sola cosa. Possiamo ricordare una frase della lettera di Giacomo: “La fede senza le opere è morta”. La Cena, l’Eucaristia, il ringraziare senza opere, senza comunicare e condividere con gli altri l’amore di Dio, è pure cosa morta.
[…]
Quando si dice “il Dio del per-dono”, “dono” qui significa regalo, “per” è un superlativo, dunque il perdono è un “grande regalo”. Dobbiamo però comprendere che non c’è un regalo senza un’esigenza. Le Beatitudini sono molto chiare in questo. Dobbiamo amare come Gesù ci ha amato. Gesù ringrazia parecchie volte e contemporaneamente è attento alla storia del suo tempo. Credo che accettare il dono di essere figli di Dio significa essere chiamati a vivere come amici, come fratelli.
[…] Le due grandi dimensioni della vita cristiana sono la preghiera, e l’azione per cambiare quello che non è degno della persona umana.
[…] Mi pare di capire che non ci sia opposizione tra le due, e questo è fondamentale per chi crede in un Dio incarnato.
[,,,] I poveri sono il nostro mondo. L’opzione preferenziale per i poveri aiuta di più a vedere le cose dal basso verso l’alto, rispetto alla visione valoriale che ci arriva dai mezzi di comunicazione, in mano sempre ai ricchi…
a cura di Matteo Attori